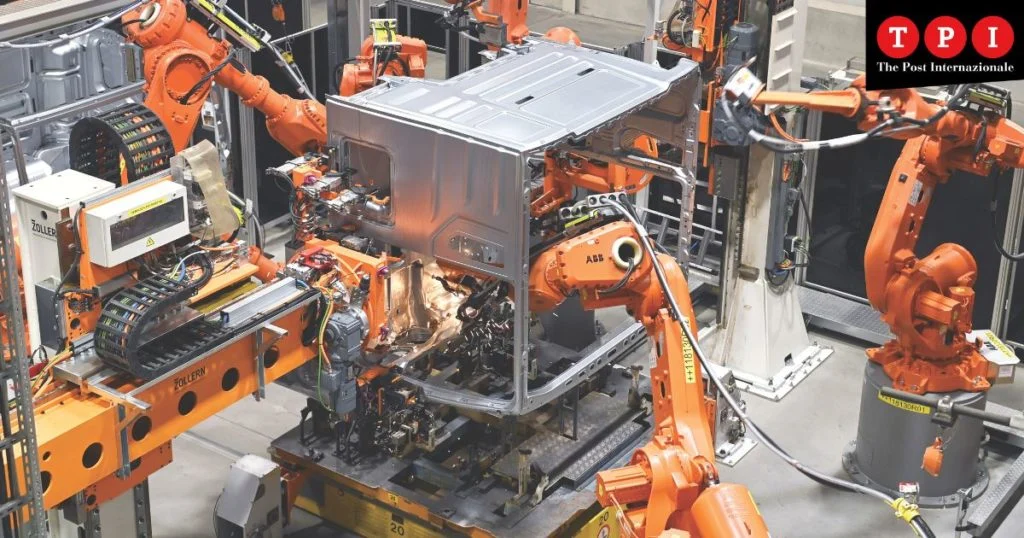Barbara Tarantino, classe 1970, vive a Roma e ha due figli, maschi, ormai due ragazzi. Gestisce un progetto noto in città, la sartoria sociale della “casa per le donne e centro antiviolenza Lucha y siesta” che si trova nel quartiere Tuscolano, un laboratorio molto attivo, nel quale si realizzano vestiti, capi di abbigliamento su misura, riparazioni, si svolgono anche corsi di formazione e che proprio il prossimo 9 marzo compirà i 16 anni di attività. Barbara Tarantino è arrivata qui (anche) perché è stata licenziata, “a causa” di una maternità.
«Lavoravo in un grande negozio di abbigliamento del centro della Capitale, con un ottimo stipendio e un contratto part time», racconta a TPI. «Ma dopo quattordici anni di impiego sono stata licenziata, formalmente per cause economiche. Ricordo ancora a memoria le parole del datore di lavoro, alludendo a me e ad altre due colleghe: “Non posso tenere tutte e tre, tirate a sorte e decidete voi chi se ne va”. Diciamo che i miei datori di lavoro non si aspettavano che sarei rimasta di nuovo incinta a quarant’anni!». Sic.
E come leggerete dagli altri racconti in queste pagine, sono frequenti i casi dei datori di lavoro che decidono o pensano di poter decidere quando e se una donna lavoratrice può mettere al mondo un figlio. «I miei principali, allora, mi fecero sentire in colpa, per essere rimasta incinta una seconda volta», continua Tarantino. «In realtà, grazie al percorso che ho fatto dopo, negli anni, ho capito quante piccole e grandi ingiustizie e molestie mi fecero subire. Come chiudere la serranda, pesante, all’ottavo mese, senza preoccuparsi mai del mio stato di gravidanza».
Oggi quel negozio ha abbassato la saracinesca per sempre. E Tarantino, vittima di una ingiustizia subita come conseguenza della sua maternità, ha trovato un lavoro migliore. «Non guadagno più come allora», aggiunge. «Ma ho ritrovato la parte artistica, il mio talento, che era stato sepolto. Ho riscoperto la passione per il mio ambito, la sartoria, e la trasmetto a tante donne, con le quali condivido anche un percorso di impegno e consapevolezza».
L’impegno di attivismo e cittadinanza di cui la donna parla, è quello di cui è protagonista all’interno di “Lucha y Siesta”, che è molto di più di un centro antiviolenza. È un luogo dove è possibile ricevere sostegno legale, psicologico, sanitario. È uno spazio fisico dove esiste una vera e propria comunità, dove tutte contribuiscono alla gestione del luogo senza separazione tra le donne che ci vivono e quelle che ci lavorano.
Madri e politica
Qui, al civico n.10 di Via Lucio Sestio, all’interno di questo villino rosa che assomiglia a un vecchio casale di campagna ma circondato dalla modernità dei palazzoni novecenteschi di Cinecittà, e dove si respira un’altra idea di Città lontana dalla Capitale del rancore che è diventata Roma, una attivista di questo spazio è anche Michela Cicculli, presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità, che la sua maternità l’ha vissuta anche in un luogo della politica. E ha fatto, tra l’altro, una battaglia molto concreta per cambiarlo. Insieme alla consigliera Nella Converti del Pd, infatti, le due consigliere di Roma Capitale, l’anno scorso, hanno ottenuto un cambio di regolamento d’aula per garantire a mamme, papà e caregiver di partecipare alle sedute dell’assemblea da remoto, intervenendo e votando quando richiesto, come se fossero in presenza. Una possibilità che fino all’ottobre 2023 non era prevista. «Siamo riuscite a introdurre questa modifica con un accordo politico unanime», dice Cicculli.
«Dopo che si era pensato al Covid ma non alla genitorialità. Non si tratta di una cosa scontata, perché non poter seguire le sedute significa rinunciare all’attività politica, in molti casi, basti pensare che a Monza una consigliera comunale si è dimessa per lo stesso motivo (Francesca Dell’Aquila, consigliera comunale del Pd e neomamma, ndr). «Abbiamo quindi voluto colmare un vuoto normativo anche per le cariche elettive, in questo caso svantaggiate rispetto ad altri ruoli. Ma siamo inserite, come donne e madri, in un sistema in cui assentarsi da una sede politica ha comunque effetti negativi», prosegue. «Oltre alla possibilità di seguire le sedute da remoto, inoltre, abbiamo raggiunto un accordo sulla possibilità di andare in aula e avere uno spazio attrezzato per l’allattamento e il cambio dei bambini».
A Roma, nel 2024, che una sede istituzionale abbia un fasciatoio è una novità, insomma. «Siamo ancora in un contesto in cui la città non è pronta ad accogliere i primi mesi dalla nascita di un bambino o una bambina», conclude Cicculli. «Occorre che lo spazio pubblico diventi uno spazio anche per genitori, dobbiamo pensare una città più accogliente. La politica, non c’è che dire, è in ritardo e lo dimostra il fatto che fino all’anno scorso il provvedimento da noi introdotto non era mai stato pensato». Alla faccia della parità di genere e della retorica governativa pro-famiglia, dunque, l’Italia non è un Paese per madri che lavorano. Ed è questa la fotografia che emerge dal racconto delle lavoratrici madri.
Agosto 2023: l’inganno
Simona (il nome di fantasia ma la sua storia è vera) è una lavoratrice di 35 anni che dopo un periodo di maternità, al suo secondo figlio, dovrà rientrare in azienda. La donna è impiegata all’interno di una azienda metalmeccanica della Lombardia. Ha un contratto part-time a tempo indeterminato, e lavora lì dentro da 12 anni, un’impresa che ha più di 100 dipendenti. Ad agosto a Simona “offrono”, anzi, in qualche modo, le impongono, di tornare al lavoro con un impegno a tempo pieno. È ovvio il tentativo dell’azienda di metterla in difficoltà, come madre, e come lavoratrice. Così, Simona si rivolge al sindacato per veder riconosciuti i propri diritti, perché con due figli, di cui uno appena nato, l’estensione dell’orario di lavoro non è una opzione né un’ipotesi praticabile.
In un primo momento, però, la lavoratrice, il rappresentante sindacale e i vertici dell’azienda si incontrano e trovano un accordo: la donna sarà occupata in mansioni diverse dalle sue, fino al 31 dicembre dello stesso anno. Un accordo che però sa di beffa, è un inganno che però la donna scopre solo quando, al termine di quel periodo considerato, l’azienda vuole risolvere ugualmente il rapporto di lavoro. E ci riesce. Alla lavoratrice non rimane, così, che ricevere una buonuscita pari a circa un anno di lavoro e la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione, per circa due anni. Perché la donna in questi casi non ha altri strumenti che quello di accettare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
«L’hanno fatta fuori», commenta Simone Grisa della Fiom Cgil Bergamo, il sindacalista che ha seguito questa vicenda. «Perché parliamo di un’azienda che non è in crisi, anzi, è in crescita sia come fatturato che come numero di dipendenti. Questa storia, così come quella di tante lavoratrici che ho avuto modo di aiutare, è costellata di pressioni e umiliazioni, di condizioni di disagio che rendono la persona più ricattabile», continua Grisa. «Non è un episodio isolato. Mi occupo di casi analoghi tra le due e le quattro volte all’anno, su un bacino di aziende nel quale seguo circa 5mila lavoratori. E il più delle volte si trova un accordo economico. Per me, come sindacalista, è un fallimento. Per le lavoratrici, a trenta, quarant’anni, essere licenziate significa poi ripartire da zero. Non è per niente facile. Molti datori di lavoro fanno di tutto per mettere in difficoltà le lavoratrici madri. Molti, non tutti, preferiscono mettere mano al portafoglio, piuttosto che garantire loro un’occupazione e la possibilità di vivere la loro maternità».
Secondo il sindacalista, molti datori di lavoro sembrano sempre infastiditi dalle necessità familiari. «Dà fastidio persino l’allattamento, garantire quelle ore di assenza dal posto di lavoro è qualcosa che non viene visto come un sacrosanto diritto per le lavoratrici», conclude. «Le aziende non sono amiche delle mamme, dalla mia esperienza emerge questo, purtroppo».
Battaglie e ricatti
C’è una donna che qualche tempo fa è stata addirittura accusata di furto dall’azienda metalmeccanica lombarda per cui lavorava; era una ragazza giovanissima, di 21 anni, che in lacrime si rivolse alla Fiom Cgil per essere aiutata. Ma l’impresa la ricattò. L’accusa era infondata ed era chiaramente soltanto un pretesto per licenziare la donna perché aspettava un bambino. Così, per il ritiro della denuncia, l’operaia fu costretta ad accettare il licenziamento insieme ad un accordo economico. E questo sostenne il padrone davanti ai sindacalisti che volevano aiutarla: «Non me l’aspettavo che sarebbe rimasta incinta così giovane». Tant’è.
C’è il dolore e l’umiliazione che spesso provano le donne che non riescono a ribellarsi e denunciare. E c’è chi sceglie per questo di non diventare madre. «Oggi nel settore che seguo, quello della logistica, la situazione sta migliorando», dice a TPI Samuela Benvegnù, segretaria generale della Uiltrasporti Verona-Vicenza. «Stiamo riscontrando che i datori di lavoro negli ultimi tempi preferiscono non rinunciare a lavoratrici formate, ma in passato c’era un vero e proprio far west senza regole. Pensate che nell’ambito della logistica della moda esisteva un consorzio che aveva proprio come abitudine quella di licenziare le lavoratrici in gravidanza. Esistevano delle violazioni dei contratti sistematiche da parte delle imprese aderenti a questo raggruppamento, spesso favorite dalla giungla dei contratti precari e dai cambi appalti. Poi siamo riusciti a trovare degli accordi con le aziende per scongiurare i licenziamenti di sei dipendenti in gravidanza e, da allora, la situazione è molto cambiata nella logistica veneta. Anche e soprattutto grazie al coraggio delle lavoratrici che si sono ribellate alle logiche padronali, e rivolte al sindacato», conclude.
Più di recente, invece, restando all’ambito dei trasporti, la sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma (presidente Donatella Casablanca) ha accertato il carattere discriminatorio della condotta attuata da ITA Spa, consistita nell’esclusione delle candidate in stato di gravidanza dalla procedura di selezione e assunzione quali assistenti di volo; «ordinando alla società la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria mediante la selezione e assunzione di Piera Angela Licari e Martina Mariani quali assistenti di volo», si legge nella sentenza, e «condannando ITA Spa al risarcimento del danno determinato in € 22.206,90 in favore di ciascuna delle odierne appellanti, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo».
Quanto ai fatti riscontrati, era accaduto che le due lavoratrici, dipendenti di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, con mansioni di assistenti di volo ed anzianità decorrente dal mese di gennaio 2011, avevano inoltrato, in considerazione dell’imminente cessazione delle attività di volo di Alitalia SAI, domanda di “adesione” a ITA Spa mentre si trovavano in stato di gravidanza.
Per tutta risposta, la società subentrante, che nel corso del reclutamento del nuovo personale, aveva attinto pressoché esclusivamente al bacino dei dipendenti del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria, nonostante la totalità degli assistenti di volo attualmente in forza in ITA risulti infatti composta da ex dipendenti Alitalia, aveva escluso le due dipendenti dalla selezione del personale da assumere.
Così, è stata accertata dal giudice di secondo grado una discriminazione. Non solo. Risulta che anche altre colleghe delle due donne, in stato di gravidanza o in puerperio, alle quali era inibita l’attività di volo, non erano state assunte da ITA Spa. Sul punto, la giudice ha osservato nella sentenza che «la condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio esprime anche una valenza dissuasiva perché elide il vantaggio che la società resistente ha inteso assicurarsi evitando l’assunzione di assistenti di volo in gravidanza». Tradotto: un datore di lavoro, prima di discriminare delle donne perché in stato di gravidanza, dovrà pensarci due volte. Così come del resto un’imprenditrice come Elisabetta Franchi avrebbe certamente pesato di più le proprie parole, se avesse saputo che dopo le sue dichiarazioni nel maggio del 2022 su donne, maternità e lavoro, avrebbe scatenato una battaglia inizialmente ingaggiata da cinque giornaliste: Sara Giudice, Giulia Cerino, Francesca Nava, Valentina Petrini e Micaela Farrocco, a cui se ne sarebbero aggiunte poi tante altre.
Cioè, la nascita della campagna pubblica #Senzagiridiboa, per «prendere posizione contro chi sostiene pubblicamente e implicitamente che sia più importante l’età anagrafica delle competenze. Che vuole lottare contro un sistema che spinge a scegliere i lavoratori sulla base del genere e non delle capacità, contro un sistema che teme la maternità (e la genitorialità) senza rivendicare invece un fatto in cui noi fortemente crediamo: un figlio aggiunge e non toglie, mai», si leggeva nel testo di presentazione.