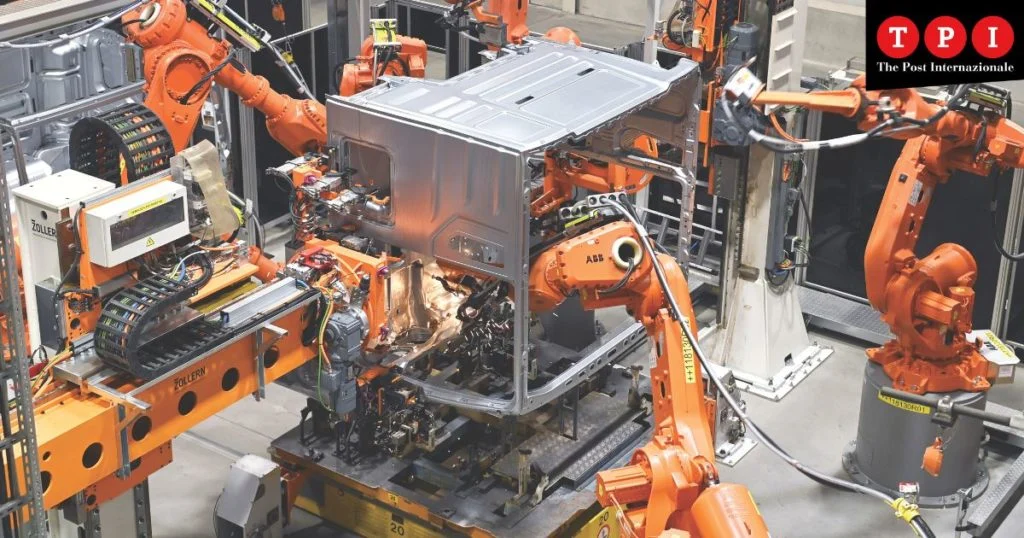È arrivato quel momento dell’anno in cui sentiamo parlare di Cop. Non è il supermercato, ma l’acronimo di Conference of Parties (Conferenza delle Parti) dell’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima. In modo meno altisonante, il più grande evento globale e anche il più ampio circo mediatico sulla questione climatica, a cui partecipano i capi di Stato, quest’anno anche re Carlo e il Papa, i primi ministri, i lobbisti, le aziende, il mondo della ricerca, personaggi dello spettacolo e della musica, gli attivisti che cercano di farsi sentire e mettere pressione.
Però dopo l’edizione del 2021 a Glasgow, che fu inondata da una marea di decine di migliaia di manifestanti, sembra si sia persa l’idea di una Cop partecipata all’esterno, con quest’ultimi impossibilitati ad avvicinarsi alle sedi dei negoziati: l’ultima Conferenza è stata a Sharm el-Sheikh, in Egitto, un Paese noto per il rispetto dei diritti umani, e quella di quest’anno si tiene all’Expo City di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che è invece uno Stato conosciuto per la sua indipendenza dai combustibili fossili.
Diminuisce il numero di attivisti e attiviste e cresce il numero dei lobbisti dell’industria fossile, che se contati assieme già a Glasgow costituivano una delegazione più numerosa di qualsiasi Stato, e che a Sharm el-Sheikh sono ancora aumentati fino a essere 700.
Contraddizioni
Il presidente della Cop28 è il sultano Ahmed Al Jaber, che riveste anche il ruolo di ministro dell’Industria, dirigente della Emirates Development Bank, inviato per il clima emiratino e soprattutto di amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), una delle più impattanti aziende petrolifere al mondo.
Al Jaber si è recentemente espresso a favore di un aumento degli investimenti annuali verso i produttori di combustibili fossili di circa 600 miliardi di dollari fino al 2030, che secondo Climate Action Tracker sono incompatibili con la promessa di azzerare le emissioni entro il 2050, e nei giorni scorsi la Bbc e The Guardian hanno rivelato di aver ottenuto dal Centre for Climate Reporting dei documenti inediti preparati dal team di Cop28 in vista di alcuni incontri bilaterali tra lo stesso Al Jaber e rappresentanti di 27 governi nell’ambito degli scambi diplomatici prima del summit sul clima. In 15 punti dei documenti trapelati emerge l’intenzione della compagnia di Stato degli Emirati Arabi di lavorare con quelle nazioni per sfruttare i loro giacimenti di petrolio e gas.
Nel dialogo ad esempio con la Cina, Adnoc afferma di essere «disposta a valutare congiuntamente le opportunità internazionali di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr)» in Mozambico, Canada e Australia, mentre propone di dire alla Colombia, che a inizio anno ha annunciato che non autorizzerà più nuove esplorazioni di gas e petrolio, di essere «pronta» ad aiutarla a sviluppare le sue riserve. Notevole ma non sorprendente.
Più sorprendente è il fatto che ancora oggi, in piena crisi climatica, istituzioni locali e internazionali abbiano la faccia tosta di assegnare posizioni apicali ad aperti negazionisti, come il nuovo capo del comitato scientifico del Ponte sullo Stretto Alberto Prestinizi, o ex dirigenti di aziende fossili, come il neo-commissario europeo dell’Azione per il clima Wopke Hoekstra, che ci rappresenterà alla Cop dal momento che l’Unione europea è l’unica organizzazione sovranazionale tra le 198 Parti che aderiscono all’Unfcc che tratta, almeno ufficialmente, come un soggetto unico.
Ci si può e ci si deve arrabbiare, soprattutto quando questi cortocircuiti accadono a casa nostra, ma bisogna anche fare i conti con la realtà: il meccanismo Nazioni Unite non è indipendente, non impone; sono i Paesi che ne fanno parte ad autoimporsi.
In questo momento l’Onu ha spesso le mani legate e calante autorevolezza, al punto che il Governo israeliano di Benjamin Netanyahu si azzarda a distorcere la parole pronunciate dal segretario generale Guterres arrivando a chiederne le dimissioni.
Il sistema Cop che ne discende è un sistema fallace, altrimenti non sarebbero stati necessari 26 anni e altrettante Conferenze per citare i combustibili fossili nel testo dell’accordo raggiunto alla penultima edizione. Ma è anche l’unico sistema che abbiamo. Una delle poche occasioni rimaste in cui si siedono allo stesso tavolo ucraini e russi, palestinesi e israeliani, armeni e azeri, cinesi e statunitensi.
Se in particolare i presidenti di questi ultimi si stringono la mano, come accadde nel settembre 2015 e come è accaduto poche settimane fa anche se in forma meno significativa, si può arrivare a risultati storici come l’Accordo di Parigi.
Cosa c’è sul tavolo
Provare a coordinare le politiche di Paesi molto diversi è uno sforzo immane e doloroso, ma è l’unico modo per avere un impatto. Le Cop, benché fonti delle Nazioni Unite affermino che l’utilizzo del loro svolgimento per promuovere interessi nazionali sia «assolutamente non» consentito, sono ricchissime di incontri paralleli, «side events», e veri e propri accordi tra un numero più ristretto ma comunque significativo di Paesi.
Quello su cui ci sarà più attenzione quest’anno è sicuramente l’impegno a triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, già lanciato dal G20 di settembre a Nuova Delhi e sostenuto da 60 Paesi. Su quest’obiettivo puntano molto gli Emirati Arabi Uniti e Irena, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, che è presieduta, sorpresa sorpresa, nientemeno che dallo stesso Al Jaber.
È un accordo importante, ma non basta aggiungere rinnovabili all’equazione senza togliere fossili, anzi, le prime sono spesso usate come distrazione per poter continuare a estrarre le seconde, la cui eliminazione graduale, benché sostenuta dall’Unione europea, difficilmente troverà spazio nei testi negoziali.
Lo scontro più aspro tra i Paesi più ricchi e responsabili e il cosiddetto G77, quelli più poveri e colpiti, si svilupperà proprio attorno ai tempi e termini di uscita da carbone, petrolio e gas e al tema del “Loss and Damage”, un sistema riparativo delle perdite e dei danni dovuti alla crisi climatica che se operativo diverrebbe il più ampio strumento di giustizia climatica esistente.
Se ne parlava da anni, ma il suo sorprendente inserimento nel testo finale dell’accordo della sciagurata Cop di Sharm el-Sheikh e, nei mesi successivi, la vittoria degli Stati Uniti, che lo contestano e che hanno ottenuto di affidarne la gestione alla Banca Mondiale, danno ancora una volta prova del fatto che le Cop sappiano essere delle imprevedibili montagne russe.
Sempre più prevedibili sono invece le conseguenze della crisi climatica se la comunità internazionale non si decide a reagire con forza. E sempre più accurati sono gli scenari delineati dalla comunità scientifica, che, in assenza della società civile concentrata sull’assedio di Gaza, nel mese di novembre ha eretto un muro di dati, ricerche, pubblicazioni allo scopo di alzare il più possibile la pressione: l’Adaptation Gap Report, il Production Gap Report e l’Emissions Gap Report dell’Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, in cui spiccano una parola, gap, divario, e un’espressione: «Disco rotto».
Il Word Energy Outlook, il report dell’Agenzia Internazionale dell’Energia che mette nero su bianco il fatto che il settore fossile stia contribuendo solo all’1% del cambiamento energetico in corso e che «i produttori di petrolio e carbone oggi devono scegliere tra peggiorare la crisi climatica o diventare parte della soluzione». E ancora la relazione Global Annual to Decadal Climate Update dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale che annuncia «nuovi livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni».
Diplomazia
Queste premesse, specialmente lo scoop della Bbc e del Guardian, portano la temperatura alle stelle all’inizio della Cop, che si tiene in un luogo già di suo caldo e distopico. E l’intensificarsi delle ondate di caldo, delle inondazioni e della siccità viste nell’ultimo anno la rendono un vertice cruciale per accelerare l’azione per il clima.
In una lettera pubblicata su Le Monde, 180 difensori del clima hanno scritto che è «assurdo e oltraggioso» che a ospitare la conferenza sul clima siano gli Emirati Arabi Uniti, settimo produttore mondiale di petrolio, quinto per riserve di gas e quinto per emissioni.
Hanno ragione, ma hanno anche ragione le Nazioni Unite che operano nel difficile tentativo di mettere d’accordo tutti i Paesi del mondo per una sfida che può essere vinta solo collettivamente da tutti i Paesi del mondo: uno dei modi per farlo, è organizzare la Cop ogni anno in un’area diversa del mondo, all’interno della quale gli Stati solitamente si mettono d’accordo scambiandosi favori, come stiamo vedendo anche per eventi come l’Expo o i Mondiali di calcio, e avanzando un’unica candidatura che l’Unfccc non può rifiutare, anche perché essa dispone degli stessi fondi di un Comune italiano di circa 40.000 abitanti e a finanziare l’evento è il Paese ospitante.
A Dubai le Parti saranno costrette almeno a un – si spera più di uno – momento di responsabilità: il Global Stocktake misura quanto fieno c’è in cascina, sarà il primo bilancio globale dei progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, che al momento sono del tutto insufficienti. Il mondo non si salva nelle due settimane in cui si tiene la Cop, che però ha il compito di creare le condizioni affinché questo avvenga. È un esperimento di governance globale unico nella storia, in cui contano le parole dette, quelle non dette, i dettagli, le virgole, e che ogni anno riesce a essere, nonostante tutto, imprevedibile.