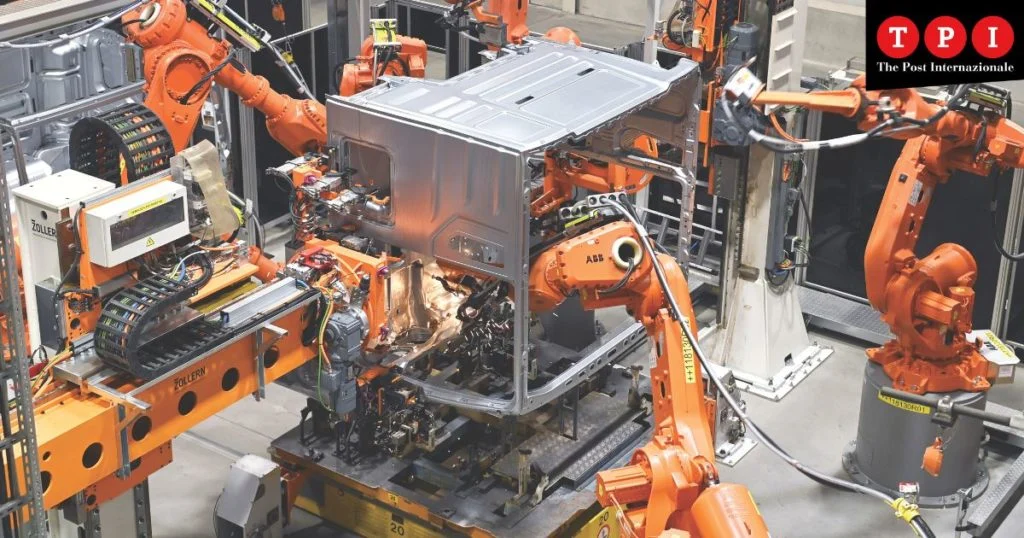Rocco Palombella fu assunto come operaio all’Ilva di Taranto lo stesso giorno del suo diciottesimo compleanno. Era il 5 dicembre 1973 e l’acciaieria – che all’epoca apparteneva allo Stato italiano e si chiamava Italsider – viveva una fase di espansione poderosa: ai tre altiforni già installati ne erano appena stati aggiunti due, uno di quali potentissimo (in grado di produrre 2,5 milioni di tonnellate all’anno).
Ogni giorno 30mila dipendenti varcavano i cancelli della fabbrica, inaugurata appena nove anni prima alla presenza del presidente della Repubblica, il socialdemocratico Giuseppe Saragat. Con i suoi oltre 15 milioni di metri quadrati di superficie, quello di Taranto era il più grande stabilimento siderurgico d’Europa.
«In città tutti ambivamo a essere assunti lì», ricorda Palombella «L’acciaieria significava lavoro garantito. Molti pescatori e calzolai smisero i panni dell’artigiano per andare a fare gli operai. L’Italsider rappresentava una speranza, quasi un’aspirazione».
Da allora è passato mezzo secolo. Ed è cambiato tutto. Oggi Palombella ha 68 anni ed è segretario generale della Uilm, il sindacato dei metalmeccanici della Uil. Il suo ufficio è a Roma, ma l’Ilva è ancora al centro della sua vita.
L’epoca d’oro dell’acciaieria è finita da un pezzo: adesso l’imperativo numero uno – per Palombella e per i suoi colleghi della Fiom-Cgil e della Fim-Cisl – è trovare un modo per evitare che il mega-stabilimento chiuda miseramente, lasciando in mezzo alla strada quel che rimane della sua forza lavoro: 8.200 addetti, a cui ne vanno aggiunti altri 2.500 sparsi fra il sito genovese di Cornegliano, Novi Ligure e altri piccoli impianti in Piemonte e Lombardia.
Ma il leader della Uilm è tutt’altro che ottimista: «In cinquant’anni non ho mai visto una situazione del genere. Penso davvero che stavolta siamo alla fine».
Il quadro
Sono ormai undici anni – da quando cioè, nel 2012, la magistratura sequestrò gli impianti a caldo di Taranto ritenendoli fonte «di malattia e morte» – che gli operai dell’Ilva vivono sospesi nell’incertezza, fra cambi di proprietà, tiramolla giudiziari, cassa integrazione e promesse regolarmente tradite.
Ma nelle ultime settimane la situazione è precipitata: i soldi in cassa sono finiti, le banche non concedono più finanziamenti, i creditori bussano di continuo alla porta e la fornitura del gas che alimenta gli unici tre altiforni rimasti è assicurata in default grazie a un provvedimento ad hoc di Arera (che però è scaduto il 30 settembre). Di fronte a questo quadro disperato, il presidente Franco Bernabè ha rimesso il suo mandato nelle mani del Governo auspicando in tempi rapidi una nuova iniezione di risorse pubbliche.
Proprio dall’esecutivo, però, arrivano notizie che lasciano presagire l’ennesimo colpo di scena: Palazzo Chigi sta lavorando in gran segreto a un nuovo accordo con Arcelor Mittal, la multinazionale indiana (con sede in Lussemburgo) che dal novembre 2018 detiene il controllo dell’Ilva.
L’intesa – salvo sorprese – dovrebbe cestinare il piano di “nazionalizzazione” (al 60%) che era stato concordato dalla stessa multinazionale tre anni fa con il Governo Conte 2 e che era stato portato avanti negli ultimi mesi con convinzione anche dal ministro meloniano delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.
Oggi gli impianti dell’Ilva sono gestiti dalla joint venture Acciaierie d’Italia (Adi): il 62% è in mano a Mittal, il 38% fa capo a Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti interamente partecipata dal Ministero dell’Economia (ma i diritti di voto sono spartiti al 50% ciascuno).
L’ingresso in partita dello Stato – o meglio, il suo rientro dopo la privatizzazione degli anni Novanta – è stato deciso nel dicembre 2020, dopo che gli indiani erano stati sul punto di andarsene in polemica con la cancellazione dello scudo penale in loro favore.
Per entrare come socio di minoranza, Invitalia ha versato due anni fa 400 milioni di euro, ma l’accordo prevedeva che entro maggio 2022 – scadenza poi rinviata a maggio 2024 – il partner pubblico avrebbe effettuato un ulteriore aumento di capitale da 680 milioni di euro: a quel punto, i rapporti di forza si sarebbero invertiti, con Invitalia al 60% a guidare le operazioni con un proprio manager di fiducia e Mittal al 40%.
La strada per il ritorno di Ilva sotto il controllo dello Stato, dunque, era tracciata. Inizialmente anche il Governo Meloni sembrava deciso a proseguire in quella direzione, tanto che lo scorso gennaio il Ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un esborso proprio da 680 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia.
Ma ora le cose sono cambiate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha di fatto esautorato il ministro Urso e affidato il dossier Ilva a due dei suoi uomini più fidati, fra l’altro entrambi pugliesi: il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Da quando sono subentrati loro, il piano di “nazionalizzazione” è stato accantonato.
Sprechi pubblici
A Palazzo Chigi adesso si lavora a un’intesa tutta nuova con Arcelor Mittal che non dovrebbe intaccare il pacchetto di maggioranza indiano né tantomeno la governance di Acciaierie d’Italia, con l’amministratrice delegata Lucia Morselli, scelta dalla multinazionale, che dovrebbe restare saldamente al comando (a Invitalia spetta solo la presidenza, affidata dal Governo Draghi a Franco Bernabè, manager ex Eni ed ex Telecom).
Il problema è che negli ultimi due anni lo Stato italiano ha già iniettato complessivamente più di un miliardo di euro nelle casse del gruppo siderurgico. Quel denaro sarebbe dovuto servire a far salire Invitalia al 60%.
Ora, invece, si scopre che le chiavi resteranno in mano a Mittal, sotto la cui gestione – oltretutto – le cose non sono affatto migliorate, anzi sono sensibilmente peggiorate, crollando da una produzione annua di 6 milioni di tonnellate ai 3 milioni previsti per il 2023, il minimo storico (a fronte di una capacità di quasi 9 milioni). In altre parole, lo Stato ci mette i soldi ma a tenere le redini saranno ancora i privati indiani.
«Sono state sperperate risorse pubbliche senza una logica», scuote la testa Palombella. E il discorso – fa notare – si può applicare anche agli ammortizzatori sociali. «A Taranto ci sono 5.500 addetti in cassa integrazione: 3mila dal 2019, quando l’azienda era totalmente in mano a Mittal, più altri 2.500 che fanno ancora riferimento alla gestione commissariale precedente. Sono lavoratori che da anni prendono un sussidio pubblico sebbene non ci sia alcuna crisi del settore acciaio né lo staccio di un piano industriale».
«In questo modo – fa notare il sindacalista – lo Stato continua a spendere soldi senza risolvere mai nulla, senza nessuna prospettiva. È la dimostrazione che la politica non è in grado di trovare soluzioni. Si tira sempre e solo a campare».
Altiforni stremati
Arrivati a questo punto, il segretario generale della Uilm teme che lo stabilimento tarantino sia ormai fatalmente destinato a chiudere. Riesce anche a fare una previsione sui tempi: «Chiuderà all’inizio del 2025, ma forse anche prima, se mancherà la liquidità».
C’è infatti una questione più strettamente tecnica che, secondo il sindacalista, si continua a sottovalutare, o almeno a tenere nascosta: «Attualmente sono in funzione tre altiforni: l’1, il 2 e il 4. Ma l’1 e il 2 sono a fine vita, potranno andare avanti per un anno o poco più, mentre il 4, che avrebbe davanti a sé ancora quattro anni, non può assolutamente reggere da solo l’equilibrio del gas in rete. Con un solo altoforno, insomma, lo stabilimento non può marciare».
E allora, continua con amara consapevolezza Palombella, «se teniamo conto che per fare qualsiasi investimento, si parla del forno elettrico e di rifare l’altoforno 5, servono minimo due anni, significa che la fine dello stabilimento si consumerà tra circa un anno e due/tre mesi». Uno scenario da brividi, per i 10.700 dipendenti del gruppo: «Che ne sarà di quei lavoratori? È quello che mi chiedo anch’io, non ci dormo la notte», confida il leader Uilm.
Eppure, a sentire l’amministratrice delegata Morselli, pare non ci sia da preoccuparsi. «L’azienda è completamente diversa da quella di quattro anni fa, è più bella e più forte», ha assicurato un paio di settimane fa la manager a margine di un evento a Bari. «Non è un momento brutto per noi, ma per chi se ne vuole in qualche modo occupare senza averne motivo».
Parole davanti alle quali Palombella sbotta: «Da una parte l’amministratore delegato sostiene che va tutto bene, dall’altra il presidente (Bernabè, ndr) dice che l’azienda “non è bancabile”. Non è paradossale, di più!».
Nelle scorse settimane il sindacalista se l’è presa anche con lo stesso Bernabè per la sua richiesta al Governo di pompare nuovi fondi pubblici verso Acciaierie d’Italia: «Non è accettabile – ha scritto in una lettera – che chi rappresenta lo Stato nel Cda non sia stato in grado di invertire la rotta in un’azienda con una gestione fallimentare. Se è vero, come ha sempre detto (Bernabè, ndr), che all’interno del Cda non ha voce in capitolo, come mai per la seconda volta cerca di condizionare il Governo sulla necessità di finanziare un’azienda che fa acqua da tutte le parti?».
Il segretario generale della Uilm chiede che si «eviti ancora una volta di far bruciare risorse allo Stato senza una reale soluzione industriale e occupazionale».
Il socio privato Arcelor Mittal, da parte sua, sostiene di aver investito in questi quattro anni circa 2 miliardi di euro sull’Ilva: «Hanno fatto gli investimenti ambientali, che erano obbligati a fare, ma non quelli tecnologici», chiosa Palombella. Il vero nodo da questo punto di vista, tuttavia, è che nella primavera 2021 Acciaierie d’Italia è stata scorporata dalla multinazionale: da allora gli indiani non hanno più mostrato alcun interesse per le sorti finanziarie della loro controllata italiana.
Così il piano decennale di decarbonizzazione da 5,5 miliardi di euro, che dovrebbe passare attraverso l’installazione di un nuovo forno alimentato a elettricità, sembra un’utopia. Ma anche il rifacimento dell’altoforno numero 5 – più volte annunciato in questi anni – appare come un miraggio.
I perché di un dietrofront
All’inizio di ottobre è circolata l’indiscrezione – riportata da Il Giornale e subita smentita da Adi – di un imminente ritorno all’amministrazione straordinaria.
I fari adesso sono puntati sulle prossime mosse del Governo. Che negli ultimi mesi sembra effettivamente aver apparecchiato la tavola per lasciare l’Ilva nelle mani di Mittal. Su iniziativa del ministro Fitto, infatti, l’esecutivo ha varato una serie di norme che vanno incontro ai desiderata della multinazionale: da un lato, è stato ripristinato l’agognato scudo penale; dall’altro è stato previsto che, nel caso in cui il sequestro degli impianti tarantini disposto dalla magistratura diventasse definitivo, lo stabilimento avrebbe una sorta di salvacondotto e potrebbe continuare a produrre.
Certo, però, resta una domanda: perché il Governo, tutto a un tratto, ha cambiato idea sulla “nazionalizzazione”? In attesa di chiarimenti pubblici, si possono fare solo ipotesi. E la più verosimile è che – soprattutto in una fase di ristrettezze di bilancio come questa – si sia preferito evitare di imbarcarsi in un’avventura così dispendiosa: un conto è avere il 40% di un’azienda iper-indebitata, un altro conto è averne il 60%. Al ché si potrebbe però obiettare che un conto è avere il 40% e non contare nulla e un altro conto è avere il 60% e avere potere decisionale. A maggior ragione se ci si è già fatti carico di pompare nel gruppo più di un miliardo di euro.
Intanto, a Taranto crescono la rabbia e lo sconforto. La città è tappezzata di manifesti polemici, finanziati dai sindacati, che ironicamente celebrano l’amministratrice delegata Morselli «per lo straordinario risultato raggiunto: minimo storico di produzione». Ma in città c’è anche chi non vede che l’ora che la fabbrica dei veleni si spenga finalmente restituendo al territorio quell’aria pulita che non si respira da decenni.
«Sta venendo giù tutto. Questo è il momento peggiore della storia dell’Ilva», riflette scoraggiato Palombella. Com’è lontano quel 5 dicembre 1973. Sembrava fosse l’inizio di una lunga epopea industriale, ma era solo un’illusione. Il sogno dorato si è trasformato in un incubo di fumi tossici, inganni, carte bollate e spreco di tempo e denaro. Adesso, forse, non resta che attendere che il sipario cali per sempre.