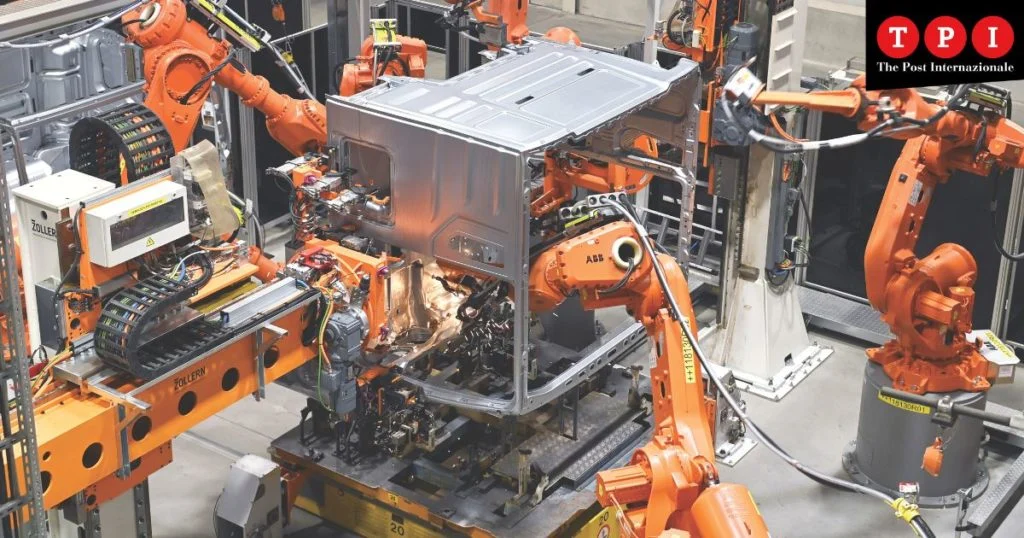È passato poco più di un anno da quando Arabia Saudita e Iran hanno annunciato un accordo che ha spiazzato le cancellerie occidentali. Dopo anni di tensioni che hanno infiammato il Medio Oriente, il 10 marzo dell’anno scorso i due Paesi hanno dichiarato di aver siglato un’intesa a Pechino per normalizzare le proprie relazioni diplomatiche. Un successo per la diplomazia cinese, raggiunto senza il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Come scritto dal New York Times, l’accordo ha «sovvertito la diplomazia mediorientale» e «sfidato gli Stati Uniti», lasciando Washington in disparte. Dopo il ritiro precipitoso degli Stati Uniti dall’Afghanistan, l’intesa era vista da alcuni come l’ulteriore segnale di una nuova era “post-americana” in Medio Oriente.
A voler ridurre l’impegno nella regione, secondo molti osservatori, sono gli stessi Stati Uniti, come parte della “svolta” verso il Pacifico promessa da tutti gli ultimi presidenti a partire da Obama. Le speranze di Washington sono riposte in un riassetto degli equilibri mediorientali, affidato ai suoi partner più stretti nella regione, ossia Israele e i Paesi del Golfo. Divise da sempre dalla questione palestinese ma unite dalla preoccupazione dell’Iran, negli ultimi anni Tel Aviv e le capitali del mondo arabo sono sembrate più vicine che mai a un altro accordo che, nelle parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe «cambiato per sempre il Medio Oriente».
Sulla pelle dei palestinesi
Voluti da Donald Trump e promossi anche dall’amministrazione Biden, finora gli Accordi di Abramo hanno consentito a Israele di normalizzare i rapporti con Bahrein, Emirati Arabi Uniti e anche Marocco, eludendo la questione palestinese. La promessa per il governo Netanyahu era quella di superare l’ostracismo storico dei Paesi arabi senza fare concessioni significative sul fronte palestinese. Gli attacchi del 7 ottobre hanno scombinato tutti questi scenari.
Cinque mesi di guerra, e più di 30mila morti, hanno dimostrato che la causa palestinese non può essere accantonata ed è ancora in grado di delegittimare qualsiasi accordo che i regimi arabi possono stringere con lo Stato ebraico. L’incapacità di rimuovere Hamas, obiettivo della campagna militare che ha devastato la Striscia di Gaza, costringe Israele a venire a patti con un nemico che ormai considerava domato. Lo shock del 7 ottobre, in cui hanno perso la vita più di 1.100 israeliani e oltre 200 sono stati presi in ostaggio, ha rotto la promessa alla base del successo di Netanyahu, che per anni ha offerto agli elettori sicurezza senza concessioni ai palestinesi. I rapporti sempre più stretti tra Israele e le monarchie arabe non sono neanche bastati a controbilanciare l’influenza dell’Iran, uno dei presupposti degli accordi.
Ogni cosa è illuminata
Come osserva Gregg Carlstrom, corrispondente dell’Economist, in un articolo su Foreign Affairs, l’influenza degli Stati Uniti sulla regione è «innegabilmente in declino». L’amministrazione Biden non riesce a convincere il governo israeliano ad ammettere l’ipotesi di uno Stato palestinese e finora non è riuscita a riportare l’Autorità nazionale palestinese a Gaza. Nonostante la dimostrazione di forza, con l’invio di portaerei nel Mediterraneo e i bombardamenti in Iraq e Yemen, Washington non è riuscita a impedire gli attacchi nel Mar Rosso contro navi che le forze filoiraniane Houthi considerano legate a Israele o ai suoi alleati.
Un egemone tanto «indifferente» quanto «inefficace», che non è in grado di imporsi né sulle milizie filo-iraniane sparse nella regione né sull’alleato israeliano che rifiuta di seguire la sua linea sulla soluzione dei due Stati. Ma anche l’unica potenza con una presenza militare significativa in tutta la regione, in cui ci sono più di 40mila truppe statunitensi. Sia Russia che Cina sono invece da considerarsi «invisibili» perché di fatto non sono ancora «potenze mediorientali».
Per Mosca, secondo Carlstrom, l’intervento in Siria nel 2015, a sostegno del regime di Bashar al-Assad, è stato il culmine della sua influenza nella regione. Già nel 2019 ha dovuto incassare una sconfitta in Libia, dove le forze di Khalifa Haftar da lei sostenute non sono riuscite a conquistare Tripoli. La Cina sta scegliendo invece di non svolgere un ruolo significativo nella crisi attuale, anche nei casi in cui vengono toccati direttamente i suoi interessi, come per gli attacchi Houthi nel Mar Rosso.
Il risultato è un «vuoto di potere» che né gli Stati del Golfo né Israele possono riempire, mentre l’Iran può solo sperare di fare da guastafeste. Una realtà presente anche prima del 7 ottobre ma portata alla luce dalla guerra, che si è limitata a «spazzare via le illusioni».
La svolta inaspettata
Sembrano lontani i proclami dello scorso settembre, quando Netanyahu annunciava alle Nazioni Unite una «svolta drammatica». «Questa pace contribuirà notevolmente a porre fine al conflitto arabo-israeliano e incoraggerà altri Stati arabi a normalizzare le loro relazioni con Israele», aveva dichiarato il premier israeliano, parlando dell’accordo per normalizzare i rapporti con Riad.
Durante il suo intervento all’Assemblea generale aveva però mostrato una mappa della cosiddetta “Grande Israele”, in cui lo Stato ebraico occupava tutti i territori palestinesi, estendendosi dal Mediterraneo fino al fiume Giordano. Una scelta che aveva scatenato forti polemiche. «Coloro che pensano che la pace possa prevalere in Medio Oriente senza che il popolo palestinese goda dei pieni diritti nazionali legittimi si sbagliano», aveva sottolineato il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen).
In un’intervista con la Cnn, Netanyahu aveva dichiarato che l’accordo avrebbe «cambiato il Medio Oriente per sempre», abbattuto «muri di inimicizia» e creato «un corridoio di gasdotti energetici, linee ferroviarie, cavi in fibra ottica, tra l’Asia attraverso l’Arabia Saudita, la Giordania, Israele e gli Emirati Arabi Uniti». Si era però rifiutato di specificare quali concessioni Israele sarebbe stata disposta a offrire ai palestinesi per arrivare all’accordo.
Anche il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, si era espresso in termini enfatici, definendo il possibile patto come «il più importante accordo dai tempi della Guerra fredda». Sulla questione israelo-palestinese, il principe si era limitato ad auspicare che l’accordo avrebbe consentito di «arrivare a un punto che faciliterà la vita dei palestinesi».
Dopo gli attacchi del 7 ottobre e lo scoppio della guerra su Gaza, le dichiarazioni su questo punto si sono fatte più nette. A seguito di un incontro di bin Salman con Antony Blinken a febbraio, il regno ha ribadito la posizione «ferma» sulla questione palestinese e «sulla necessità che il fraterno popolo palestinese ottenga i propri diritti legittimi».
A pesare sulla posizione di Riad è prima di tutto il consenso interno. Secondo un sondaggio condotto dal Washington Institute for Near East Policy dal 14 novembre al 6 dicembre, il 96 per cento degli intervistati ritiene che «i Paesi arabi devono interrompere immediatamente ogni contatto diplomatico, politico, economico e qualsiasi altro contatto con Israele, per protestare contro la sua azione militare a Gaza».
Nonostante la ferma contrarietà dell’opinione pubblica, per molti sostenitori degli Accordi di Abramo il solco è tracciato. «Gli Emirati Arabi Uniti hanno preso una decisione strategica e le decisioni strategiche sono a lungo termine», ha dichiarato a gennaio Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, che ha poi ammesso: «Non c’è dubbio che qualsiasi decisione strategica dovrà superare molteplici ostacoli e noi siamo di fronte a un ostacolo importante che deve essere affrontato».
Una posizione destinata a essere impopolare nel mondo arabo. Secondo un altro sondaggio dell’Arab Center Washington DC e dell’Arab Center for Research and Policy Studies, condotto dal 12 dicembre al 5 gennaio su un campione di ottomila residenti in 16 Paesi arabi, il 67 per cento valuta la posizione di Abu Dhabi «male o molto male», il 64 per cento ha un parere negativo della posizione dell’Arabia Saudita e il 54 per cento di quella egiziana. Tra le possibili risposte all’offensiva israeliana su Gaza, il 36 per cento ritiene che i governi arabi debbano rinunciare a ogni relazione o allo stesso processo di normalizzazione con lo Stato ebraico.
Malgrado gli «ostacoli» alla normalizzazione, l’Arabia Saudita ha chiarito che non intende rinunciare all’accordo, pur esigendo maggiori concessioni sulla questione palestinese. Secondo quanto dichiarato a febbraio dal ministero degli Esteri saudita, non ci saranno «relazioni diplomatiche con Israele a meno che non venga riconosciuto uno Stato palestinese indipendente sui confini del 1967», l’anno in cui Israele occupò la Cisgiordania e Gaza durante la Guerra dei sei giorni. Il ministero ha anche esortato i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad «accelerare il riconoscimento dello Stato palestinese», chiedendo il ritiro delle «forze di occupazione israeliane» dalla Striscia di Gaza. Successivamente, Riad ha messo in guardia Israele dalle «gravissime ripercussioni dell’assalto alla città di Rafah nella Striscia di Gaza».
Patronato esterno
Così come le trattative sulla normalizzazione, anche l’accordo tra Arabia Saudita e Iran è sopravvissuto, almeno per il momento, alla guerra a Gaza. A quattro giorni dall’inizio del conflitto, il presidente iraniano Ebrahim Raisi e bin Salman hanno tenuto la loro prima conversazione telefonica dalla ripresa dei rapporti diplomatici, in cui i due leader hanno concordato sulla «necessità di porre fine ai crimini di guerra in Palestina» e di promuovere «l’unità islamica». A novembre il presidente iraniano si è recato a Riad per la prima volta dal 2012, per prendere parte al vertice congiunto della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) su Gaza.
I rapporti tra i due Paesi erano interrotti dal 2016, dopo l’esecuzione del religioso sciita Nimr al-Nimr da parte di Riad e le proteste in cui erano state attaccate le missioni diplomatiche saudite in Iran. Per anni la rivalità tra la monarchia sunnita e la repubblica degli ayatollah ha alimentato tensioni in Paesi come la Siria, il Libano, l’Iraq, il Bahrein fino allo Yemen, dove l’Arabia Saudita è intervenuta militarmente contro i ribelli filo-iraniani Houthi. La campagna militare, iniziata nel 2014 dopo la presa della capitale Sana’a da parte dei ribelli sciiti, ha alimentato una guerra che ha avuto conseguenze umanitarie disastrose, senza riuscire nell’intento di sconfiggere gli Houthi, che hanno lanciato attacchi missilistici e droni sul regno saudita.
Nonostante l’accordo, Riad e Teheran continuano a sedere su sponde opposte. Mentre il regno saudita continua a mantenere stretti legami economici e militari con i Paesi occidentali, con una vendita da 582 milioni di dollari di armi autorizzata da Washington lo scorso dicembre, la Repubblica islamica si sta legando sempre di più a Russia e Cina. Teheran è accusata dall’Occidente di aver fornito a Mosca droni, bombe aeree guidate, artiglieria e munizioni, utilizzati dalle forze russe in Ucraina. A metà marzo ha preso parte insieme a Russia e Cina a un’esercitazione militare congiunta nei pressi del Golfo dell’Oman. Denominata “Marine Security Belt 2024”, ha coinvolto più di 20 navi oltre a elicotteri navali in un’area di 17.000 chilometri quadrati considerata di importanza strategica.
Circa il 20 per cento del petrolio scambiato a livello mondiale transita infatti nello Stretto di Hormuz, che collega il Golfo di Oman al Golfo Persico. Un segnale che la rivalità tra i fronti contrapposti «si sta scaldando», ha commentato l’esperto Meir Javedanfar all’emittente statale americana Voice of America. A queste parole ha risposto indirettamente il cinese Global Times, citando un esperto militare: «Cina, Iran e Russia hanno iniziato a tenere regolarmente esercitazioni congiunte nella regione molto prima delle attuali tensioni in Medio Oriente», ha scritto la testata controllata dal Partito comunista cinese. «Crediamo che i popoli del Medio Oriente siano i padroni del Medio Oriente», aveva detto nel 2022 il ministro degli Esteri cinese durante un incontro con gli omologhi di sei Paesi mediorientali. «Non c’è mai un “vuoto di potere” e non c’è bisogno di un “patronato esterno”».