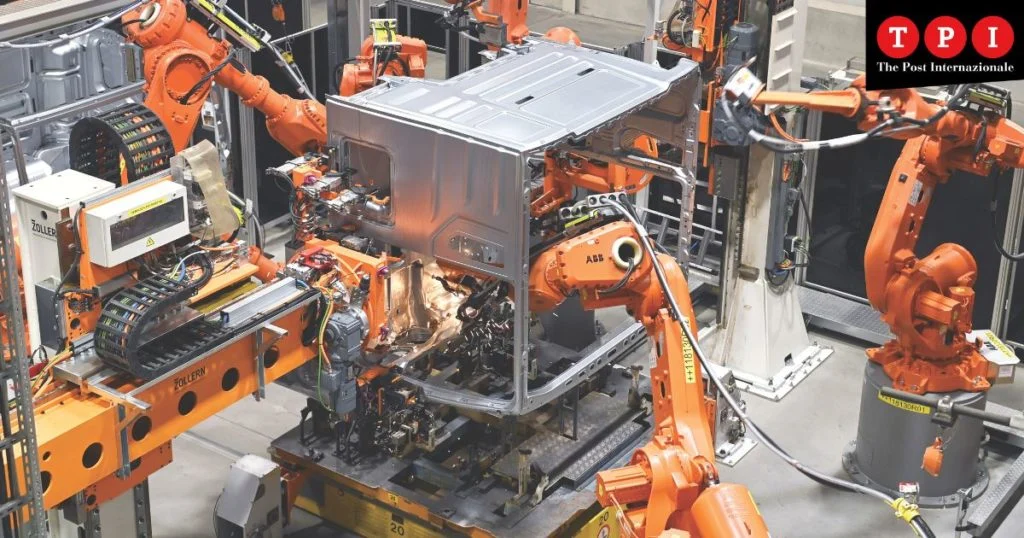Quando Joe Biden ha annunciato dalla Casa bianca il lancio aviotrasportato di «cibo e rifornimenti» in aiuto della popolazione di Gaza alla presenza di una Giorgia Meloni apparsa piuttosto sorpresa, il presidente degli Stati Uniti ha confuso due volte la Striscia con l’Ucraina.
Al di là del facile sarcasmo sull’età avanzata di Biden e della crudele ironia degli aiuti inviati da Washington a una popolazione stremata dai bombardamenti compiuti da Israele con munizioni di fabbricazione statunitense, il lapsus rivela forse le reali priorità degli Usa.
Mentre a Washington (come a Doha, al Cairo e a Parigi) si discute, a Gaza si muore e si continuerà a morire anche dopo la guerra. Nemmeno un cessate il fuoco può fermare la carneficina, viste le condizioni in cui è ridotta la popolazione della Striscia. Un territorio il cui futuro resta in bilico tra la voracità di terra della destra di Israele, la mancanza di credibilità dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) e il disinteresse della comunità internazionale, finora non pervenuta sulla ricostruzione.
“Non esiste un dopo”
Chi ha le idee chiare su che fine faranno la Striscia di Gaza e i suoi 2,3 milioni di abitanti palestinesi è invece la frangia più estrema dei coloni israeliani, che trova appoggi importanti nel governo presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Non a caso alla “Conferenza per la vittoria di Israele” tenuta il 28 gennaio scorso a Gerusalemme e il cui motto era: “Gli insediamenti portano sicurezza: il ritorno nella Striscia di Gaza e nella Samaria settentrionale”, erano presenti ben 11 ministri e 15 deputati della maggioranza, compresi alcuni del partito Likud guidato dal premier.
Ma tra i tremila partecipanti in festa, accorsi numerosi agli stand informativi allestiti sotto una grande mappa della Striscia che segnalava gli ipotetici nuovi insediamenti israeliani (illegali), c’era anche Daniella Weiss, leader dell’organizzazione Nachala, che ben prima del 7 ottobre aveva ottenuto il tacito appoggio del governo di Tel Aviv per riaprire la colonia precedentemente smantellata di Evyatar, in Cisgiordania.
Fu lei a dire alla stampa presente al convegno di Gerusalemme: «Gli arabi se ne andranno» dalla Striscia di Gaza. Il piano è semplice nella sua crudeltà: proprio come Israele «non dà loro cibo» per premere su Hamas affinché rilasci gli ostaggi, allo stesso modo «non dovrebbe dare loro nulla per fare in modo che se ne vadano».
Per l’ultra-destra, gli attentati si sono trasformati in un’occasione. «Il 7 ottobre ha cambiato la storia», spiegava Weiss dal palco della conferenza. «Gaza, la porta meridionale di Israele, sarà spalancata: gli abitanti se ne andranno. Non è in una terra straniera che stiamo tornando. Non esiste un “giorno dopo”: il giorno dopo è oggi, è ogni giorno in cui il popolo ebraico vince e torna a stabilirsi a Gaza». Intanto il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, parlava di «migrazione volontaria» dei palestinesi dalla Striscia e il suo collega alle Comunicazioni, Shlomo Karhi, prometteva che «non ci sarà mai uno Stato palestinese tra il fiume e il mare».
Malgrado la presunta «unità» del popolo israeliano su questo tema, rivendicata dal palco da Yossi Dagan, presidente del Consiglio regionale della Samaria e altro strenuo sostenitore delle colonie illegali, non tutti in Israele la pensano così. Tuttavia i segnali arrivati recentemente dalle urne raccontano una storia più complicata.
Alle elezioni municipali del 27 febbraio scorso, le prime consultazioni tenute in Israele dal 7 ottobre in cui 7 su 9,3 milioni di israeliani erano chiamati a votare in 197 comuni e 45 consigli regionali, i partiti ultra-ortodossi e di estrema destra hanno guadagnato consensi. Anche se l’affluenza si è attestata al di sotto del 50 per cento e nella maggior parte delle grandi città, esclusa Haifa, sono stati confermati i sindaci uscenti, il partito e gli alleati del premier Netanyahu hanno mobilitato la propria base meglio dell’opposizione, riuscendo ad aumentare i seggi in molti consigli comunali e regionali. Non si votava certo per il futuro di Gaza o del primo ministro ma i partiti che lo sostengono sul territorio hanno tenuto, mostrando che le politiche di Netanyahu trovano ancora consensi in Israele.
Ricominciare da capo?
D’altra parte era stato lo stesso ufficio del premier a rimarcare la vicinanza tra il capo del governo e l’opinione pubblica all’indomani dell’uscita del “piano” per il dopo Hamas, un documento di una paginetta che contiene i propositi ufficiali di Israele per il futuro della Striscia, in cui vengono esposti una serie di principi «ampiamente accettati dall’opinione pubblica», almeno secondo l’esecutivo di Tel Aviv.
Illustrato al Consiglio dei ministri e al gabinetto di sicurezza nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, il testo non cita mai l’Anp, l’unico organo riconosciuto da molti Stati esteri come legittimamente rappresentativo del popolo di Palestina. Il punto saliente però riguarda il controllo militare della Striscia di Gaza (e della Cisgiordania), che resterebbe saldamente in mano a Israele, intenzionato anche ad affidare l’amministrazione del territorio costiero e la responsabilità della sua smilitarizzazione a un organismo civile in grado di assicurare mano libera alle forze armate dello Stato ebraico.
L’obiettivo è avvalersi di «funzionari locali» con «esperienza amministrativa» non legati a «Paesi o entità che sostengano il terrorismo», un riferimento velato non solo a Qatar, Iran e Hamas ma, forse, anche all’Anp, che però non viene esplicitamente esclusa.
L’unica cosa certa è che il documento non prevede alcun riconoscimento di uno Stato palestinese che, si legge nel testo, «darebbe una ricompensa enorme e senza precedenti al terrorismo e impedirebbe qualsiasi futuro accordo di pace».
Intanto, lo Stato ebraico vuole mantenere il controllo anche del valico di Rafah al confine con l’Egitto, sulla cui collaborazione Tel Aviv ritiene di poter contare. Inoltre, prevede di istituire una zona cuscinetto sul lato palestinese al confine con la Striscia, che resterà operativa a tempo indefinito o meglio, come si legge nel documento, «finché ve ne sarà la necessità».
Questa parte del piano contrasta direttamente sia con le dichiarazioni dell’amministrazione statunitense che con gli impegni assunti dall’Egitto. Il presidente Usa Joe Biden ha spesso ribadito come nel dopoguerra non dovrà esserci alcuna ulteriore riduzione del territorio della Striscia, mentre Il Cairo si è rifiutato più volte di assumersi la responsabilità della sicurezza a Gaza.
Israele vorrebbe anche procedere a una completa smilitarizzazione della Striscia, gestita direttamente dalle forze armate israeliane, nonché a un programma «completo» di «de-radicalizzazione» di tutte le istituzioni religiose, didattiche e assistenziali attive a Gaza e spesso controllate da organismi vicini a Hamas. Un obiettivo da perseguire «per quanto possibile, con il coinvolgimento e l’assistenza dei Paesi arabi che hanno esperienza nella promozione» di tali iniziative. Un riferimento ai regni del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno più volte chiarito di non essere disponibili a svolgere alcun ruolo nella Striscia senza una soluzione definitiva della questione palestinese.
Per questo, l’Anp ha criticato l’iniziativa di Netanyahu, ribadendo che qualsiasi progetto per il dopoguerra che non includa la Striscia come parte di uno Stato palestinese è «destinato a fallire». Malgrado quanto dicono dall’ufficio del premier, la proposta non ha trovato molti consensi neanche in patria. Secondo l’ex diplomatico israeliano Alon Pinkas, il piano mira solo a «un controllo illimitato su Gaza senza alcuno sviluppo politico positivo». «Sotto Netanyahu, israeliani e palestinesi sono destinati, come nel film “Ricomincio da capo”, a svegliarsi ieri mattina», ha scritto invece l’editorialista Noa Landau su Haaretz. «Vuole quello che ha sempre desiderato: gestire il conflitto senza mai risolverlo».
Insomma, non cambierebbe nulla. Chi prova a invece trasformarsi è l’Anp, con una vecchia formula all’italiana: il governo tecnico.
Formula italiana
«Alla luce degli sviluppi legati all’aggressione contro Gaza», come spiegato dal premier dimissionario dell’Anp, Mohammed Shtayyeh, il governo palestinese si è dimesso lo scorso 26 febbraio per far spazio a un esecutivo di unità nazionale, composto da esperti, che dopo la guerra governi tutti i Territori, compresa la Striscia, e ne gestisca la ricostruzione e la sicurezza.
In realtà, l’avvicendamento sarebbe stato promosso sia dagli Usa che dai mediatori internazionali dell’Egitto e del Qatar. Come spiegato a Le Monde dal politologo di Ramallah, Mohammed Daraghmeh, «gli Usa chiedevano il rilancio dell’Anp sin dalle prime settimane del conflitto, così Mahmoud Abbas (Abu Mazen, ndr), preoccupato di un possibile tentativo di essere messo da parte, ha agito in maniera preventiva».
Il partito Fatah del presidente palestinese si sarebbe infatti accordato con Hamas per la formazione di un governo tecnico, di cui il gruppo armato responsabile degli attentati del 7 ottobre non farebbe parte e a cui affidare l’amministrazione di tutti i territori palestinesi. Le fazioni si sono incontrate a Mosca marzo per arrivare alla formazione di un esecutivo di unità nazionale, appoggiato anche da Qatar ed Egitto.
«È pensato per unificare i palestinesi, la loro geografia e il loro sistema politico», ha spiegato al Guardian l’ambasciatore palestinese nel Regno Unito, Husam Zomlot. «Il panorama politico è cambiato: questo è il momento di ascoltare la nostra gente, non è l’ora delle fazioni politiche. Abbiamo la responsabilità di formare un governo in grado di provvedere al proprio popolo, unire la nostra gente e il sistema politico. Il duplice compito dell’esecutivo è fornire il necessario sostegno umanitario e preparare le elezioni, nonché le riforme economiche». Non ci sono ancora delle tempistiche, anche se si comincia a fare qualche nome.
Tra i principali candidati a succedere a Shtayyeh c’è Muhammad Mustafa, attuale direttore del Palestine Investment Fund. Non è esattamente un nome nuovo ma tra tanti altri fa la figura dell’esperto. Il 70enne è stato già consigliere per gli affari economici di Abu Mazen dal 2005, poi vicepremier e ministro dell’Economia dal 2013 al 2014, quindi membro del Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) dal febbraio del 2022. Dal 2009 però guida il Fondo di investimento palestinese mentre prima, tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, è stato consulente per le privatizzazioni del Fondo saudita e poi consigliere per le riforme economiche in Kuwait.
«Cambiano le persone ma in sostanza non c’è niente di nuovo», ha notato il politologo palestinese Daraghmeh. Un segnale preoccupante per chi intende riguadagnare consensi. In un sondaggio condotto tra novembre e dicembre scorso, l’88 per cento dei palestinesi, intervistati in tutti i Territori occupati, si è detto favorevole alle dimissioni di Abu Mazen, mentre il 44 per cento degli interpellati in Cisgiordania ha affermato di sostenere Hamas, che malgrado i massacri resta più credibile dell’Anp agli occhi di molti palestinesi. Tuttavia, mentre altrove si discute, a Gaza si continua a morire.
Catastrofe umanitaria
Qui, dal 7 ottobre, sono oltre 30mila i morti e più di 70mila i feriti e circa 1,7 milioni gli sfollati. «Una persona su 20 è morta o ferita», ha denunciato in un discorso a Ginevra subito la strage l’Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk. «Compresi donne e bambini».
Secondo le Nazioni Unite, quasi tutti i residenti sono a grave rischio di insicurezza alimentare mentre solo uno dei tre acquedotti che da Israele riforniscono il territorio costiero è ancora in funzione, anche se opera solo al 47 per cento della portata massima. Soltanto due dei tre impianti di desalinizzazione delle acque sono ancora parzialmente operativi e tutti i sistemi fognari sono fuori uso.
«Tutti a Gaza sono a rischio imminente di carestia. Quasi tutti bevono acqua salata o contaminata e l’assistenza sanitaria sul territorio funziona a malapena», ha aggiunto Türk. «Immaginate cosa questo significhi per i feriti e per le persone che soffrono di malattie infettive a carattere epidemico. Nel nord di Gaza, dove lo spazio operativo per l’attività umanitaria è ormai quasi pari a zero, si ritiene che molti stiano già morendo di fame».
I minori sono tra coloro che soffrono di più. Nella Striscia di Gaza, secondo l’Unicef, quasi un bambino su 10 al di sotto dei 5 anni è gravemente malnutrito. Per Save The Children, a un migliaio di minori sono già stati amputati uno o più arti. Altri 17mila invece, secondo l’Onu, sono stati separati dalle loro famiglie e risultano non accompagnati. Più di 1 milione di giovanissimi poi ha bisogno di assistenza psicologica.
Intanto il 75 per cento della popolazione, circa 1,7 milioni di persone su 2,3 milioni di residenti, risulta sfollata. Oltre il 60 per cento delle case, quasi 360mila unità abitative, è stato distrutto (più di 70mila) o danneggiato (più di 290mila). Così 3 abitanti su 4 vivono in tende o altri rifugi di fortuna, costretti persino a mangiare cibo per animali per sopravvivere.
Ma nemmeno un cessate il fuoco immediato può fermare la carneficina. Secondo l’ambasciatore palestinese a Londra, «è probabile che altri 10mila palestinesi moriranno anche se si raggiungesse ora un cessate il fuoco».
Ma se il bilancio umano del conflitto è incalcolabile, sono già disponibili le prime stime dei costi per la ricostruzione. Il problema è che non si sa ancora chi sarà a finanziarla.
A chi il conto?
Si parla di una cifra intorno ai 50 miliardi di dollari. Soltanto 15 miliardi, secondo quanto annunciato a gennaio al World Economic Forum di Davos dal già citato direttore del Palestine Investment Fund, Muhammad Mustafa, servirebbero per ricostruire le case distrutte.
Un conto che fa impallidire i precedenti: dopo la guerra del 2014, durata sette settimane e in cui morirono circa 2.100 palestinesi, il Qatar spese oltre 1 miliardo di dollari solo in progetti abitativi a Gaza.
Stavolta però non si sa chi pagherà il conto. Secondo il Financial Times, né l’Unione europea né gli Usa sono per ora disponibili a farsi avanti, meno che mai Israele. L’ente più adatto ad occuparsene sarebbe l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), accusata da Tel Aviv di dare lavoro a 12 persone (su 13mila dipendenti) sospettate di complicità negli attentati del 7 ottobre. Motivo per cui ne chiede la chiusura, mentre i principali finanziatori dell’Agenzia, Italia compresa, ne hanno sospeso i pagamenti, mettendo a rischio gli aiuti ai civili nella Striscia.
Come dire che, comunque vada, a pagare sarà comunque la popolazione di Gaza.