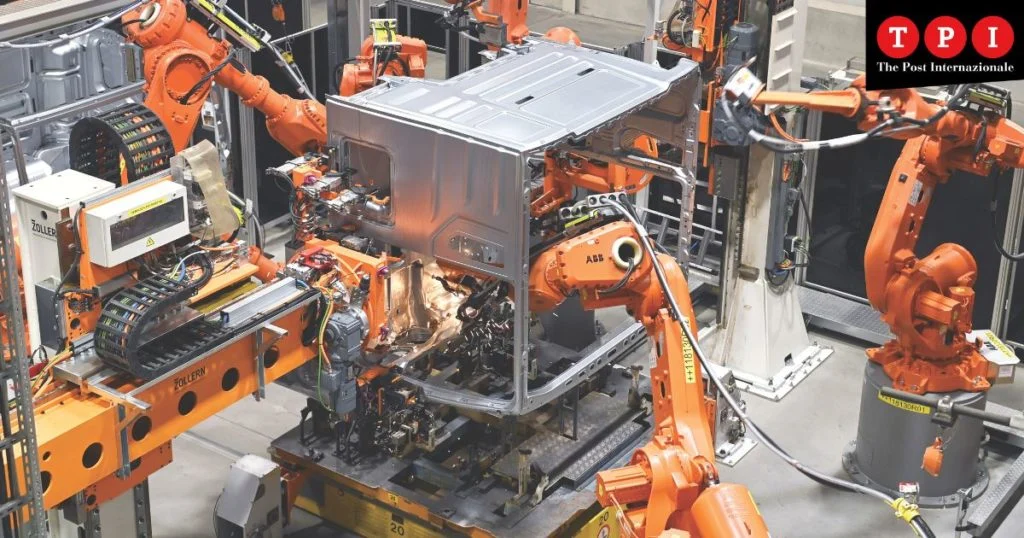Quando il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, Mostafa Waziri, ha annunciato l’ennesimo «progetto del secolo» – ossia ricostruire la facciata in granito della piramide di Micerino, a Giza – in Egitto è scoppiato il putiferio, non solo tra gli archeologi. Malgrado la prevista collaborazione dell’Università giapponese di Waseda, al di là dei dubbi degli esperti, in molti si sono chiesti chi sarà a pagare il conto. Tanto che lo stesso Waziri è dovuto intervenire in due talk show sulla tv pubblica, eludendo però la domanda se i costi del progetto saranno a carico dello Stato, già gravemente indebitato e alle prese con una crisi economica ormai quasi endemica. Alla fine, il governo del Cairo ha sospeso tutto, istituendo un comitato di revisione dell’iniziativa con tanti esperti internazionali. Ma ormai il danno era fatto.
La pretesa del regime di Abdel Fattah al-Sisi, salito al potere con un colpo di stato militare nel 2013, di rilanciare il Paese attraverso il suo passato imperiale si scontra con la realtà della crisi economica, aggravata prima dall’invasione russa dell’Ucraina, che ha aumentato il prezzo delle importazioni egiziane di grano; poi dal golpe in Sudan, che ha costretto il Paese ad accogliere centinaia di migliaia di profughi; quindi dal conflitto nella Striscia di Gaza e dall’escalation nel Mar Rosso, che ha provocato il crollo del traffico nel Canale di Suez con il conseguente dimezzamento delle entrate fiscali di una delle principali fonti di valuta estera del Cairo. Ma andiamo per gradi.
Doppio canale
A gennaio, secondo l’Autorità del Canale, lo Stato egiziano ha incassato “solo” 428 milioni di dollari dal transito di navi in entrata e in uscita tra Suez e Port Said, quasi la metà degli 804 milioni ricavati nello stesso mese dell’anno precedente. Per il direttore dell’Autorità, Osama Rabie, il numero di navigli di passaggio lo scorso mese è calato del 36 per cento su base annua, creando un danno potenzialmente gravissimo all’economia del Cairo.
Da questa rotta marittima, la più breve tra l’Asia orientale e l’Europa, passa quasi un terzo del traffico container globale: così il Canale rappresenta un’importante fonte di valuta estera per l’Egitto, che l’anno scorso ci ha ricavato oltre 10,25 miliardi di dollari di tasse.
Ma da quando i ribelli yemeniti Houthi, vicini all’Iran, hanno cominciato a bersagliare le navi in transito nel Mar Rosso per fare pressioni su Israele affinché metta fine alla guerra a Gaza, è stato l’Egitto a pagare il prezzo più alto. Colossi come Maersk e Hapag-Lloyd hanno prima alzato le tariffe e poi deviato i propri carichi verso il più lungo (e costoso) tragitto che circumnaviga l’Africa, mentre Usa e Gran Bretagna (e presto anche l’Unione europea) schieravano una missione militare nell’area, che ha acuito le tensioni. Così, dall’inizio della guerra a Gaza, il traffico attraverso il Canale di Suez si è ridotto quasi della metà. Una vera e propria beffa, visti gli oltre 8 miliardi di dollari spesi per raddoppiare l’opera nel 2015.
Ma non è l’unico settore in sofferenza a causa del conflitto. È crollato infatti anche il turismo, da cui l’Egitto ricava ogni anno quasi il 14 per cento degli afflussi di denaro in valuta estera (solo nel 2023 ha “incassato” 14 miliardi di dollari). Non che prima al Cairo navigassero nell’oro, anzi.
Una vita insostenibile
Dopo dieci anni di dittatura militare, la situazione economica e sociale in Egitto è sempre più grave. Una serie di catastrofi globali e regionali ha poi rincarato la dose: l’economia nazionale infatti è stata duramente colpita dalla pandemia di Covid e dalle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina, che ha fatto impennare i prezzi alimentari, visto che l’Egitto è uno maggiori importatori globali di grano, che arriva proprio dai due Paesi in guerra.
Secondo i dati ufficiali, il 30 per cento degli egiziani vive al di sotto della soglia di povertà, mentre per la Banca Mondiale il 60 per cento della popolazione è “povero” o “economicamente vulnerabile”. Su oltre 108 milioni di abitanti parliamo di cifre comprese tra i 30 e i 60 milioni di poveri a cui, secondo l’Unchr, vanno ad aggiungersi oltre 500mila profughi, di cui quasi la metà fuggiti dal vicino Sudan dopo lo scoppio della faida di potere in corso da aprile a Khartoum.
Una massa che oggi deve anche far fronte a un aumento incontrollato dell’inflazione, che a dicembre ha raggiunto un tasso annuo del 34 per cento. Tanto che sempre meno persone possono permettersi alimenti nutrienti come uova, latte e carne, i cui prezzi sono aumentati ancora malgrado i livelli già molto elevati raggiunti negli anni scorsi. Alla fine del 2022 infatti, il National Nutrition Institute egiziano arrivò a consigliare al pubblico di optare per gli scarti alimentari come le zampe di gallina o gli zoccoli del bestiame come alternativa proteica ed economica alla carne. La denutrizione e l’obesità dovute a una dieta di bassa qualità sono così diffuse nel Paese che, secondo l’Unicef, «due terzi della mortalità infantile può essere attribuita alla malnutrizione».
La fame non è l’unico fardello dei più poveri, che in molti casi sono assillati anche dai debiti. Una condizione di vulnerabilità che porta migliaia di persone in prigione, insieme a centinaia di migliaia di detenuti politici e presunti oppositori del regime. Secondo le stime ufficiali, quasi un quarto della popolazione carceraria egiziana è costituita da “gharemat”, donne indebitate finite in carcere perché incapaci di ripagare i creditori. Un fenomeno legato non solo alla povertà ma anche alla discriminazione, visto che in Egitto, secondo l’Istituto di statistica statale Capmas, solo l’11,8 per cento delle donne in età lavorativa ha effettivamente un impiego. Parliamo di decine di migliaia di persone: uno studio pubblicato nel 2021 dalla ong indipendente Forum per lo sviluppo e il dialogo sui diritti umani (Fhrd) contava almeno 35mila detenute condannate per debiti. Un flagello che in Egitto riguarda però anche lo Stato.
“Too big to fail”?
Oltre la metà del bilancio pubblico ormai è destinato a ripagare il debito estero, che negli ultimi dieci anni è quadruplicato mentre lo scorso marzo ha superato i 165 miliardi di dollari. Il deficit di bilancio per l’anno 2023/2024 dovrebbe arrivare a 29 miliardi di dollari, pari all’8 per cento del Pil. Intanto però al-Sisi, rieletto presidente proprio a dicembre con quasi il 90 per cento dei voti in una consultazione tutt’altro che libera, continua a spendere a spandere per i suoi megaprogetti. Come quello della nuova capitale amministrativa, in cui ha investito 60 miliardi di dollari (il 15 per cento del Pil). Tutto mentre le rimesse in valuta estera dall’estero sono in calo, la popolazione è costretta in povertà, il debito cresce e la moneta continua a deprezzarsi.
Se la disoccupazione giovanile supera il 17 per cento tra i giovani, il Paese è ormai il secondo maggiore debitore mondiale del Fondo monetario internazionale (Fmi), mentre la sterlina egiziana (complici le tre svalutazioni decise dal governo del Cairo dal 2022) ha perso almeno il 50 per cento del suo valore dall’inizio della guerra in Ucraina. Anche le rimesse dall’estero sono in calo: nel 2022 arrivarono a 31,8 miliardi di dollari (pari al 7 per cento del Pil), ma nel terzo trimestre dell’anno scorso hanno cominciato una lenta discesa, dovuta anche alla paura dei 10 milioni di espatriati di scambiare valuta pregiata con una moneta in caduta libera.
Il Cairo dipende così sempre più dai suoi partner internazionali: dall’arrivo al potere di al-Sisi, i Paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, hanno donato oltre 100 miliardi di dollari all’Egitto. Due anni fa invece il Fmi ha accordato al Cairo un programma di prestiti da 3 miliardi di dollari, a cui in queste ore potrebbero aggiungersi altri 12 miliardi, in cambio della solita ricetta fatta di riforme e austerità. Non a caso, il governo egiziano ha ridotto del 15 per cento il bilancio statale per gli investimenti pubblici e ha rinviato a giugno i nuovi progetti infrastrutturali previsti quest’anno, mentre la Banca centrale ha aumentato di due punti percentuali il tasso d’interesse ufficiale nel tentativo di frenare la corsa dell’inflazione, arrivata ormai in doppia cifra.
Al-Sisi però non sembra troppo preoccupato e continua a spendere miliardi di dollari (da aggiungere agli 1,3 miliardi assicuratigli ogni anno dagli Usa) per le forze armate, a cui ha affidato anche una serie di aziende strategiche con cui premiare i militari in congedo. Inoltre ha incassato l’ingresso nel nuovo formato Brics+ con Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia. Poi, insieme al Qatar, resta in prima fila nei negoziati tra Israele e Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza. Insomma l’Egitto, sembrano pensare al Cairo, è troppo grande per fallire, sia economicamente che politicamente. La sua caduta produrrebbe un rumore assordante nella regione e vorrà probabilmente essere evitata dalle grandi potenze sia in Occidente che in Oriente ma il contesto internazionale e i dati economici potrebbero costare molto caro all’attuale regime, salito al potere proprio in occasione di una gravissimi crisi sociale. Chissà se il Faraone se lo ricorda.