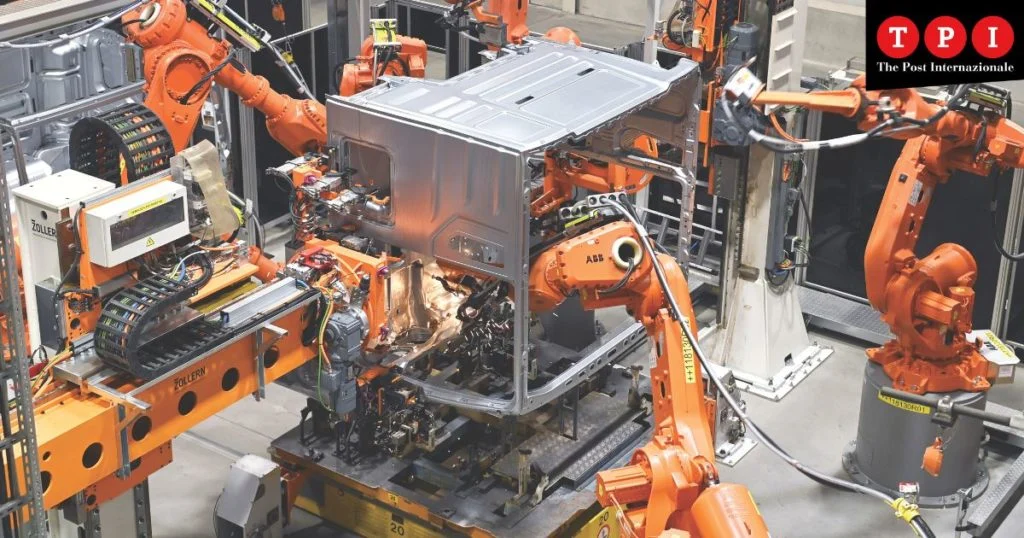Quando venerdì 3 novembre Hassan Nasrallah, leader del partito-organizzazione militare libanese sciita Hezbollah, ha preso la parola, molti temevano potesse essere l’annuncio di un ingresso del gruppo nel conflitto tra Israele e Hamas. Un timore scongiurato, anche perché per Hezbollah avrebbe poco senso affrontare oggi un esercito come quello israeliano, strutturalmente più forte, in un momento in cui il confine col Libano è in massima allerta proprio per i timori di un surriscaldamento della situazione in quell’area. Ma ciò che Nasrallah ha fatto intuire chiaramente è che Hezbollah approva qualsiasi azione rivolta contro Israele, gli Stati Uniti e i loro alleati in tutto il Medio Oriente, chiarendo che lo scambio di colpi tra il suo gruppo e lo Stato ebraico è una delle azioni più grandi che abbiano mai compiuto e non si fermerà.
Ciò che infatti ha lasciato col fiato sospeso gli osservatori di tutto il mondo all’inizio del discorso di Nasrallah è stato proprio questo, il timore che il conflitto possa allargarsi al resto della regione e che ciò non avvenga per forza con un conflitto nel senso tradizionale del termine, ma attraverso azioni ibride, le stesse azioni che molti gruppi alleati dell’Iran, compreso Hezbollah, hanno portato avanti negli ultimi anni e si stanno intensificando in questo momento particolarmente teso, all’interno di un delicato risiko che coinvolge tutta la regione mediorientale.
Minacce ibride
In questo senso, l’ultima minaccia ad aggiungersi è arrivata dall’estremo sud del Medio Oriente, più precisamente dagli Houthi, il gruppo sciita che controlla parte dello Yemen ed è uno stretto alleato dell’Iran, i cui miliziani hanno lanciato alla fine di ottobre un attacco con droni e con un missile balistico rivolti contro Israele. Per quanto sia i droni che il missile siano stati intercettati sul Mar Rosso dal sistema di difesa israeliano Arrow 5. Gli stessi Houthi, impegnati in una guerra civile nel loro Paese che li vede contrapposti a un governo legato all’Arabia Saudita, hanno più volte lanciato attacchi simili contro obiettivi di Riad, esattamente la tipologia di attacchi auspicata da Nasrallah.
Non è infatti un caso che oltre agli Houthi anche altri gruppi, spesso legati all’Iran, abbiano iniziato una serie di azioni colpendo le basi americane in Siria e Iraq, azioni cui Washington ha risposto con obiettivi legati ai Guardiani della rivoluzione iraniani nella regione. Elementi che aumentano la tensione, mentre Israele, parallelamente alla guerra a Gaza, continua a scambiarsi colpi al confine col Libano con gli Hezbollah e saltuariamente anche con la Siria sulla linea del fronte del Golan.
Diplomazia al lavoro
Intanto che la guerra non accenna a fermarsi a Gaza e dà segnali preoccupanti verso i Paesi vicini, si muove la diplomazia. A tale riguardo, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha proseguito in maniera incessante la sua agenda di viaggi, muovendosi in tutto il Medio Oriente. Al centro ci sono ovviamente molti aspetti, a partire dalla richiesta che si leva da più parti di un cessate il fuoco umanitario a Gaza, dove si teme sempre di più per la vita e l’incolumità dei civili e in modo particolare dei bambini, con le vittime che, secondo il ministero della Salute locale, avrebbero superato il numero di 10mila. Ma questo non è l’unico elemento sull’agenda di Blinken: c’è la delicata situazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Ad oggi ne sono stati liberati quattro grazie anche alla mediazione del Qatar: si tratta di due cittadine americane e due signore israeliane di 79 e 85 anni, cui va aggiunta una militare israeliana liberata durante un’operazione delle forze armate del suo Paese. Ma il numero di persone rapite durante gli attacchi del 7 ottobre ancora in mano ad Hamas non è noto con precisione: se ne calcolano almeno 250, e sulla loro sorte al momento ci sono molte incognite.
Ma mentre la diplomazia cerca di muoversi per il loro rilascio, Hamas ha reso note le condizioni: la liberazione di oltre seimila detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. Una richiesta difficile da assecondare per Israele in un momento come questo, ben diverso da quando nel 2011 rilasciò oltre mille detenuti per ottenere la liberazione di Gilad Shalit dopo cinque anni di prigionia. E in risposta, lo Stato ebraico ha rilanciato dicendosi disponibile a una tregua umanitaria solo in cambio della liberazione degli ostaggi. Un nodo che non sembra semplice da sciogliere in tempi rapidi, mentre su Gaza continuano a piovere bombe e l’esercito israeliano ha iniziato le operazioni terrestri, prendendo il controllo della fascia centrale e tagliando di fatto in due la Striscia, iniziando così un accerchiamento della città di Gaza.
Il post-Hamas
Ma c’è un’altra questione che sta molto a cuore agli Stati Uniti e non solo, e riguarda il futuro della Striscia qualora Israele riuscisse a portare a casa il suo obiettivo di mettere fuori gioco militarmente e politicamente Hamas. Il gruppo palestinese, ritenuto un’organizzazione terrorista da gran parte dei Paesi occidentali, ha il totale controllo del territorio da quando nel 2007, un anno dopo le ultime elezioni palestinesi, allontanò i membri di Fatah instaurando un regime autoritario e creando di fatto la divisione della Palestina in due soggetti differenti a Gaza e in Cisgiordania. Eliminare Hamas dalla Striscia significherebbe o lasciare il territorio in balia di sé stesso o creare un’amministrazione provvisoria, e quest’ultima non potrebbe sicuramente avvenire tramite un’autorità insediata da Israele, come lo stesso Stato ebraico ha fatto sapere.
Intorno alla questione del futuro di Gaza si sta dunque muovendo la diplomazia, e due membri del Congresso americano hanno parlato al sito Politico dicendo che l’idea è formare una coalizione che prenda il controllo della Striscia dopo la fine dell’intervento israeliano e porti avanti una transizione. Coalizione da cui gli Stati Uniti si chiamano fuori e che dunque la logica vorrebbe fosse composta da Paesi del mondo arabo. Ma nel contesto attuale, la situazione non sembra essere semplice.
Il nodo Erdogan
Nei giri di Blinken non è mancata la Turchia, dove l’accoglienza non è stata tra le più affettuose. Il 5 novembre, giorno dell’arrivo nel Paese, una folla di militanti pro-Palestina ha cercato di prendere d’assalto la basa militare statunitense di Incirlik, che tra le altre cose ospita testate nucleari parte del programma di condivisione Nato. La Turchia, unico membro dell’Alleanza atlantica in Medio Oriente, negli ultimi anni ha storicamente cercato di perseguire una propria posizione autonoma, e la guerra di Gaza non fa eccezione in questo senso. Tra il 7 ottobre e oggi, non sono mancate da parte di Erdogan le dichiarazioni secondo cui Hamas non rappresenta un’organizzazione terroristica, ma dei “mujaheddin” che difendono la loro terra, e ha cancellato un viaggio in programma in Israele. In risposta, lo Stato ebraico ha ritirato la sua delegazione diplomatica da Ankara. La Turchia, già prima di questi sviluppi, ha sempre tenuto un atteggiamento di apertura verso Hamas, il cui leader Ismail Haniyeh si è recato più volte nel Paese. Secondo lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, un centro di comando del gruppo palestinese in cui recluta uomini e organizza azioni avrebbe sede proprio in Turchia.
La discriminazione in crescita
Il Medio Oriente non è l’unica area del mondo a subire gli strascichi di questa guerra, e non sono mancati in giro per il mondo episodi di antisemitismo che, secondo molti osservatori, sono aumentati in seguito all’inizio della guerra a Gaza. In Francia ha colpito la comparsa di stelle di David lo scorso 31 ottobre a ridosso di negozi e abitazioni nel quattordicesimo arrondissement di Parigi: un episodio che ricorda drammaticamente un passato non troppo lontano, arrivato peraltro pochi giorni prima dell’ottantacinquesimo anniversario della famigerata “Notte dei cristalli”. Per l’occasione, la procura ha aperto un’indagine con l’aggravante di discriminazione. La magistratura francese ritiene possa inoltre essere legato a un movente antisemita l’accoltellamento di una donna avvenuto a Lione il 4 novembre. Ma non sembra trattarsi di casi isolati, dal momento che il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha dichiarato che nelle ultime settimane gli episodi di antisemitismo in Francia «sono esplosi». Ma la Francia non sembra essere un caso isolato: il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, ha dichiarato che il 60 per cento di crimini d’odio religioso negli Stati Uniti sono rivolti contro persone di religione ebraica da quando la guerra a Gaza è iniziata. Sempre negli Stati Uniti, un uomo ha ucciso un bambino di sei anni. La sua colpa? Essere musulmano e palestinese. L’odio, a quanto pare, non ha un’unica direzione.
L’episodio di antisemitismo che ha avuto maggiore eco, tuttavia, arriva dalla Russia, dal territorio a maggioranza musulmana del Daghestan per la precisione, dove il 28 ottobre una folla ha preso d’assalto l’aeroporto di Mahachkala alla notizia dell’arrivo di un aereo da Tel Aviv, dando inizio a una vera e propria caccia all’ebreo fortunatamente messa a freno dalla sicurezza locale. A riguardo, dal Cremlino hanno fatto sapere che sarebbe stata una provocazione sostenuta dall’Ucraina e dall’Occidente nel tentativo di disgregare la società russa, fatto negato da Kiev. Ma, a quanto pare, gli strascichi del Medio Oriente arrivano alla guerra in Ucraina e viceversa.