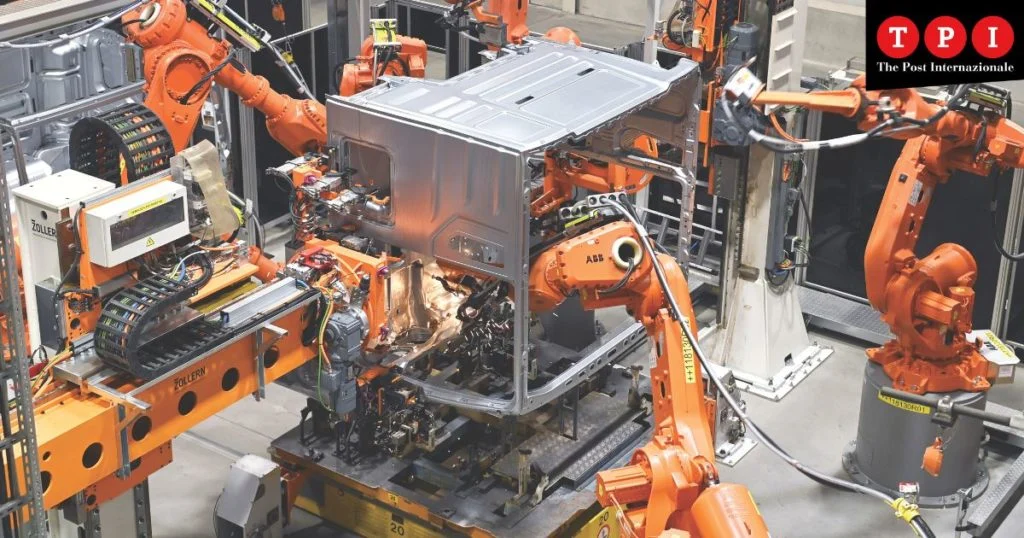Hasan Asfour ha trascorso tutta la vita passando da un Paese arabo all’altro ma non ha mai smesso di lottare per la Palestina e per la pace. Prima in Giordania, poi in Iraq, dopo in Siria – dove fu detenuto per quasi un anno e mezzo – quindi in Libano e infine in Tunisia, oggi in Egitto. A soli 37 anni, da dirigente del Partito comunista, l’ingegnere agrario prese la guida della Direzione per la Pace e la Solidarietà del Dipartimento per le Relazioni Arabe e Internazionali dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), allora guidato dall’attuale presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Col tempo divenne uno dei più stretti collaboratori di Yasser Arafat e arrivò a coordinare la delegazione palestinese alla Conferenza di pace di Madrid nel 1991. Appena quarantaduenne poi svolse un ruolo chiave nei colloqui segreti di Oslo del 1993. Più volte ministro dell’Autorità nazionale palestinese, che ha lasciato dopo la morte di Arafat, partecipò anche ai negoziati di Wye River e Camp David. «Quando lo conobbi sembrava diviso tra due convinzioni incrollabili», scrisse di lui Uri Savir, direttore generale del ministero degli Esteri israeliano ai tempi di Oslo. «La sua certezza nella perdurante arroganza di Israele e la sua fede nella possibilità di raggiungere la pace». Ma oggi sembra tutto molto più difficile.
Nel 1993, insieme ad Ahmed Qurei (Abu Ala) e Maher al-Qurd, Lei partecipò ai colloqui di Oslo. Collaborava già con Abu Mazen ma era il più giovane della delegazione palestinese. Come arrivò a presenziare ai negoziati?
«All’epoca vivevo a Tunisi ed ero un dirigente del Partito comunista palestinese. Proprio lì cominciai a occuparmi del dialogo. Il Partito mi incaricò di partecipare alla Conferenza di Madrid e poi ai colloqui di Washington del 1991. In virtù dell’esperienza maturata in queste occasioni fui scelto come membro dell’Alta commissione per le trattative che poi avrebbero portato agli accordi di Oslo».
Qual era allora il suo ruolo?
«Inizialmente dovevo rivedere la corrispondenza di Yasser Arafat e, più raramente, di Abu Mazen. Fu così che ebbi accesso per la prima volta al mondo dei negoziati».
Come si giunse ai colloqui?
«Fu il premier israeliano Yitzhak Rabin a interrompere la precedente dinamica dei rapporti con i palestinesi. Soprattutto a causa della cosiddetta “Intifada delle pietre”, scoppiata nel 1987. Un ruolo determinante lo svolsero le telecamere: il loro arrivo nelle aree occupate mostrò il volto duro e crudo dell’occupazione, i crimini commessi in nome di Israele sulla popolazione palestinese. Negli anni Ottanta era pratica diffusa da parte degli occupanti rompere mani, braccia e gambe ai ragazzini dei Territori. Il mondo finalmente vide cosa succedeva e quando quei filmati arrivarono nelle case di tutti, Rabin si trovò in difficoltà. Non era più sostenibile il modo in cui Israele vendeva la propria immagine, completamente smentita dai video girati sul campo. Fu questo a spingere il governo israeliano a un cambio di passo».
Come si svolsero gli incontri?
«Cominciammo con dei colloqui informali, inizialmente rimasti segreti. Questa prima fase durò poco più di due mesi, da fine gennaio al marzo del 1993. Lì preparammo i negoziati successivi di Oslo, che fondamentalmente vedevano coinvolto il Partito laburista di Rabin».
Filò tutto liscio?
«Uno dei problemi era che a tenere questi colloqui erano principalmente degli accademici (gli israeliani Yair Hirschfeld e Ron Pundak, ndr) e non degli esperti di diritto. Il che significava che tutto doveva poi sempre essere rivisto da dei giuristi, in modo che corrispondesse agli obiettivi delle parti coinvolte. Questo fu l’inizio delle trattative che portarono agli Accordi».
Hirschfeld e Pundak non erano dei politici ma vi fidaste subito gli uni degli altri. Perché?
«In realtà non erano solo degli accademici, entrambi erano membri del Comitato centrale del Partito laburista e di conseguenza giocavano un ruolo politico».
Insomma parlavano per Israele.
«Avevano la possibilità di ottenere udienza presso i leader del Partito politico che allora era al governo in Israele. Loro furono scelti perché potevano dialogare con noi, soprattutto nella fase informale delle trattative».
Quale fu la fase successiva?
«Nel mese di marzo chiedemmo un ulteriore cambio di passo e di andare alla prova dei fatti. Pretendemmo un nuovo livello, pubblico, dei negoziati. Altrimenti sarebbe stato inutile proseguire».
A quel punto intervenne direttamente il governo israeliano.
«Da parte loro, attraverso l’allora ministro degli Esteri Shimon Peres, inviarono ai colloqui un ambasciatore e così cominciò la fase ufficiale delle trattative».
Gli accordi alla fine naufragarono. Ma qual è la lezione di Oslo?
«La lezione dolorosamente imparata a Oslo è che Israele non è un Paese affidabile per quanto riguarda il dialogo per la pace. La prova è che, una volta arrivato a una forma di accordo, per questo lo stesso premier Rabin fu assassinato da un israeliano. L’entità sionista (Israele, ndr) ha provato di non essere in grado di vivere al fianco di uno Stato palestinese e che non è la trattativa il mezzo con cui arrivare alla pace. È davvero complicato parlare oggi di dialogo, soprattutto con l’attuale interlocutore».
Perché?
«Attualmente Israele è governato da quella stessa destra fascista dalle cui frange uscì il responsabile dell’assassinio di Rabin. A guidare le manifestazioni contro gli accordi di Oslo c’erano politici come l’attuale premier Benjamin Netanyahu e l’odierno ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che oggi guidano Israele».
C’è un filo rosso che unisce Oslo ad oggi?
«La politica portata avanti contro i palestinesi è molto chiara e si basa sul sistematico insediamento di coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Tanto che nel 1994 il numero degli abitanti di questi insediamenti illegali era pari a 174mila persone mentre oggi la cifra è cresciuta di sette volte, un’evidente violazione del diritto internazionale che segna il fallimento del dialogo, oggi impossibile, soprattutto finché Netanyahu e la sua destra fascista saranno al governo».
Cosa serve per far ripartire il dialogo?
«L’unico modo è un radicale cambio dei rapporti di forza tra le parti».
Come?
«Proclamando lo Stato palestinese. Nel novembre 2012, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione che riconobbe la Palestina (gli attribuì lo status di “Stato non membro Osservatore Permanente”, ndr). Allora, Abu Mazen avrebbe dovuto dichiarare la nascita dello Stato palestinese sotto occupazione, arrivando allo scontro diplomatico diretto. Ma decise di non farlo».
Come mai?
«Non voleva scontrarsi con gli Stati Uniti, nella speranza di un aiuto da parte di Washington che non è mai arrivato».
Cosa si aspettava?
«Stiamo aspettando da undici anni, ma non abbiamo visto alcuno sforzo, di alcuna natura, da parte degli Usa per rendere effettiva la nascita dello Stato palestinese, anzi. Nella sua ultima intervista alla Cbs, il presidente Joe Biden ha di fatto archiviato la possibilità di arrivare a una soluzione a due Stati».
A quali condizioni può riprendere il dialogo?
«Ripeto: solo con la nascita e il riconoscimento dello Stato palestinese. Perché ci possano essere delle trattative, bisogna garantire condizioni di parità per negoziare».
Negoziare su cosa?
«Due Stati che discutono tra di loro possono provare a risolvere anche le questioni più complesse: ad esempio lo status di Gerusalemme, il ritorno in patria dei profughi e dei rifugiati palestinesi della diaspora e tutti i dossier più scottanti. Ma tutto questo può avvenire soltanto dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina».
Anche la restituzione della terra e la definizione dei confini?
«Quali debbano essere i confini tra i due Stati è già stato stabilito dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, l’ultima volta proprio nel 2012, quando fu confermato che la Linea Verde del 1967 è il confine riconosciuto della Palestina».
È possibile una mediazione per fermare l’intervento a Gaza?
«È impossibile saperlo con una guerra in corso. Prima di tutto vorremmo capire quali siano i reali obiettivi di Israele in questa operazione e a quale prezzo sarà disposta a fermarsi».
Chi può mediare?
«L’Egitto e la Giordania potrebbero fare qualcosa per arrivare a una mediazione. Ma è difficile immaginarlo mentre vediamo, in diretta, il dipanarsi di crimini di guerra contro i civili, bombardamenti di ospedali, case, quartieri interi».
L’Autorità nazionale palestinese non interverrà?
«Quale governo può presentarsi davanti ai propri cittadini e dire loro che sta trattando con una potenza che li bombarda. È impossibile. Sul campo la situazione è estrema: su oltre due milioni di abitanti della striscia di Gaza, la zona del mondo a più alta densità abitativa, almeno 500mila sono sfollati. In tale contesto non è possibile instaurare un dialogo, prima di tutto devono tacere le armi e la palla, da questo punto di vista, è nelle mani di Israele».
C’è anche un problema politico tra i palestinesi, che non sono chiamati al voto da oltre 15 anni. Chi li rappresenta oggi?
«L’unico rappresentante legittimo della popolazione palestinese è e resta l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), che rappresenta anche la diaspora e non include Hamas».
Che ruolo gioca allora Hamas che, nella striscia come in Cisgiordania, ancora gode di molti consensi?
«Hamas resta una parte non trascurabile del quadro politico palestinese ma ricordiamoci che sedici anni fa ha compiuto un colpo di stato a Gaza. Quindi l’unico referente legittimo per ogni eventuale trattativa non può essere altri che l’Olp».
Ma se anche raggiungesse un accordo con Israele, l’Olp riuscirebbe poi a imporlo a Hamas?
«L’Olp ha tutti i mezzi, gli strumenti e i meccanismi per poter comunicare e coordinarsi con tutti i movimenti palestinesi, anche quelli che non ne fanno parte come Hamas. È l’unico rappresentante legittimo dei palestinesi».
Da dove cominciare?
«L’Olp ha riconosciuto lo Stato di Israele. Ora Israele deve riconoscere la Palestina, solo così ci sarà parità al tavolo del negoziato».
Con la collaborazione di Fouad Roueiha per la traduzione dall’arabo