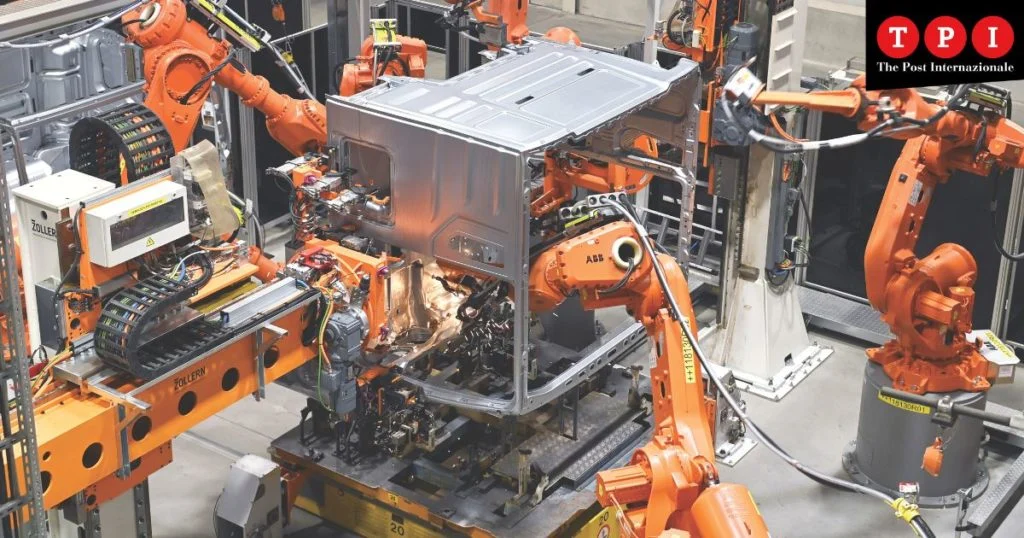Sono bastati dieci giorni di fuoco per mettere in crisi quello che Giorgia Meloni ha di più caro: il suo racconto. Il berlusconismo decadente e crepuscolare degli ex “berluscones” di destra finiti nell’occhio del ciclone della giustizia – Apache La Russa e suo padre Ignazio, Daniela “Pitonessa” Santanchè e Vittorio Sgarbi sessista – è per la leader di Fratelli d’Italia come la krypronite per Superman: un veleno che si inocula nel sistema immunitario, fiacca ogni energia, distrugge la narrazione della destra nazionale, moderna, conservatrice, «underdog», madre e donna, peggio delle cluster bombs di Joe Biden.
«Non sono ricattabile», ruggiva la Meloni il giorno in cui il Cavaliere l’aveva sfidata, raccogliendo così le simpatie trasversali di tanti italiani di destra, ma anche di sinistra. Vero: lei non è ricattabile, ma “loro” sì.
Giorgia è romana, proletaria, cresciuta in una famiglia di sole donne, temprata nella sobrietà (la sua adorata Mini, il rifiuto della scorta), l’apologia della militanza. “Loro” sono nordici, maschilisti e talvolta misogini (Sgarbi ha fatto indignare la regista Cristina Comencini), appariscenti (Filippo Facci ha fatto giochi di parole sullo stupro), inguaiati con la magistratura (e non certo per un complotto): i berluscones amano la bella vita, le belle macchine, le cose di lusso, le bottiglie millesimate, svuotate nei locali “fighi”.
Giorgia nella sua gavetta faceva la babysitter (di Fiorello) e la barista, mentre gli articoli sul presunto ma terribile stupro di Milano parlano di un locale (quello dove è iniziato tutto) che è già un veleno per la caratterizzazione popolare dei fratelli meloniani.
Stili di vita
La serata più lunga di Leonardo Apache La Russa inizia al bancone dell’esclusivissimo Apophis, roba per ragazzi di buona famiglia e figli di papà, 500 euro di tessera solo per entrare, 2mila per una serata irrorata. Esclusivismo, Milano bere.
Giorgia era i manifesti che attaccavano – «Erba? Roba da conigli!» – i ragazzi del Fronte di Colle Oppio. Leonardo Apache faceva arrabbiare papà Ignazio esibendosi nella lingua terribile dei trapper: cantava «Sono tutto fatto/ e fotto» o «Voglio la Pussy/ nel privée».
Ovvio che l’arte non sia la vita, e che il ragazzo non è colpevole fino a una condanna (applico a lui il garantismo che Ignazio La Russa non ha applicato alla ragazza che ha denunciato alla violenza). Ma qui non parliamo di processi e indagini, che arriveranno negli anni, ma di stili di vita, di un immaginario che si è abbattuto in un nanosecondo sulla più limpida identità politica costruita in questi anni con un lavoro di fatica e di cesello.
Se poi aggiungi a questo incerto rap misogeno e da sballo i quattordici falsi cognomi del compagno della ministra Santanchè – “Principe-Dimitri Kunz-d’Asburgo-Lorena-Piast-Bielitz-Bielice-Belluno-Spalia-Rasponi Spinelli-Romano- Miesko-Leopoldo” (si è scoperto da una nota degli Asburgi Lorena, quelli veri, che è un tarocco, in realtà un nome proprio registrato a San Marino”) – e poi ti soffermi sulla Maserati 5000 con il leasing pagato dalla società che sta fallendo, e ha sei milioni di euro debiti, e se poi provi a pensare alla casa al Pantheon da 19mila euro mese della ministra, che esalta le sue capacità imprenditoriali nel discorso del Senato ma non paga la cassa integrazione ai suoi dipendenti, capisci subito che da una nobile esaltazione di militanza siamo passati a una grossolano remake di “Riccanza”.
Quindi, ovviamente, tutti ci auguriamo che “Larus” Leonardo Apache La Russa possa provare la sua innocenza sul piano giudiziario, ma nessuno potrà dimenticare quel comunicato pieno di stereotipi da avvocati specializzati in processi di stupro, incredibilmente vergato (e subito ritrattato) dalla seconda carica dello Stato: «Ho interrogato mio figlio e so che non ha commesso reati», «la ragazza era drogata», «ha denunciato dopo 40 giorni», «io e mia moglie l’abbiamo incrociata e stava benissimo», e la perla «una sola cosa non posso perdonare a mio figlio: aver portato a casa una ragazza con cui non aveva un rapporto stabile».
Pitonesserie
Quando era stato Ciro Grillo a registrare un video in cui si sostenevano le stesse tesi – la vittima colpevolizzata, i dubbi, i ritardi, la droga – la leader di Fratelli d’Italia aveva vergato parole di fuoco che sarebbero state perfette anche in questo caso. Ma dal giorno dello scoop del Corriere della Sera la presidente del Consiglio ha preferito non commentare le parole di La Russa, e si è accontentata delle parziali scuse del presidente del Senato.
Così come non è intervenuta dopo il grottesco monologo del sottosegretario Sgarbi, al Maxxi: un lungo e compiaciuto vaniloquio a colpi di «cazzo», «figa», «prostata», «scopate», in cui Sgarbi giungeva – nientemeno – ad esaltare Fidel Castro: «Se ne è scopate trentamila, viva il comunismo!».
Immaginate le reazioni esterrefatte delle mamme moderate che avevano apprezzato il racconto (autentico) della ragazza partita dalla Garbatella per approdare a Palazzo Chigi: adesso si ritrovano al governo il dongiovannismo crepuscolare e priapistico di Sgarbi, la bella vita e le pitonesserie, le stilettate da avvocatorum di La Russa.
Giorgia vede sventolare sui banchi del suo esecutivo come vessilli l’innovazione dei bavagli e delle leggi ad personam, che io definisco l’ultima avvelenata eredità del berlusconismo. Perché è davvero curioso che dopo non essersi piegata a Silvio quando era vivo, forte e carismatico, adesso la Meloni debba mandare giù le grottesche caricature che ne fanno i suoi pallidi epigoni.
E qui – per capire il perché – basta un fotogramma del dibattito parlamentare sull’inchiesta per falso in bilancio e bancarotta che riguarda la Santanchè. Daniela parla in aula, La Russa presiede, Maurizio Gasparri lo sostituisce a fine turino.
Chi ricorda la zoologia politica dei primi anni Duemila sa bene che questi erano i vertici della destra protagonista di An, quelli dove i “Gabbiani” della Meloni e di Fabio Rampelli (il suo maestro) e Federico Mollicone (il suo tutor) trovarono rifugio quando ruppero il cordone ombelicale con la loro famiglia originaria, quella della destra sociale rautiana.
Almirante addio
Ma anche con l’almirantismo questi berluscones hanno poco a che vedere: il Msi era l’unico partito insieme al Pci che non aveva un solo indagato nello scandalo P2, era – anche con Gianfranco Fini – il partito di Mani Pulite.
Era il Movimento Sociale che cingeva il parlamento con Teodoro Buontempo e i giovani Gabbiani (era il 1993, c’erano sia Rampelli che Mollicone) al grido di «Arrendetevi, siete circondati!» con tanto di biglia di ferro scagliata che infrangeva simbolicamente la vetrata dell’ingresso principale di piazza Montecitorio. Marco Pannella riuniva gli inquisiti del pool al cinema Capranichetta e i deputati missini gridavano «Noi siamo con Mani Pulite!».
In quei giorni il deputato più fascistissimo e intransigente, Carlo Tassi – indossava solo camice nere! – mi regalava i bigliettini a fondo nero con queste due scritte: frontespizio «Onorevole Carlo Tassi – patriota», retro «Viva Di Pietro!». E bandierina tricolore.
Gli uomini di quella destra – il catanese Benito Paolone, Buontempo – ti raccontavano: «Guarda che Tonino è missino, come lo era Paolo Borsellino, ex camerata nostro e militante del Fuan». L’almirantismo e il rautismo affondavano le loro radici in questa storia: nessun inquisito in Tangentopoli, «Noi abbiamo le mani pulite!», «Guardatemi negli occhi!», manifesto con un primississimo piano degli occhi celesti di Almirante.
Ed erano quelli che si emozionavano quando ricordavano che negli anni di piombo il segretario missino, che Giorgia aveva eletto a padre politico, gridava dai palchi: «Se un terrorista è di destra, allora per lui ci vuole la doppia pena di morte!». Ogni condanna era un applauso.
Oggi gli eredi del Msi popolare cresciuto nel mito dell’onestà si ritrovano impantanati nella guerra ai magistrati. E la Meloni, che si è portata a Palazzo Chigi il sobrio e rigoroso magistrato Alfredo Mantovano, adesso è costretta a tacere sul caso La Russa e a vergare note informali di Palazzo Chigi, dopo essere stata scottata (anche) dal rinvio a giudizio di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia ed esponente della cosiddetta “generazione Atreju”, ovvero la nidiata di Azione Giovani.
Solo che la rivelazione di Delmastro al suo onorevole compagno di casa, nonché coordinatore nazionale di Fdi, Andrea Donzelli sembra una storia da studenti fuorisede, e la simpatia di cui gode un po’ ovunque il deputato (celebri sono suoi collegamenti provocatori a L’Aria che tira) non è intaccata.
Il caso Santanchè, invece, sembra fatto apposta per rinnovare tutti gli stereotipi della Casta: la ministra si prende la macchina di lusso in comodato d’uso (77mila euro l’anno!), poi però impone alla scorta di usare la sua e non quella di servizio, poi raccoglie 450 multe nell’area B di Milano (e non le paga).
Dice la Santa: «É l’auto di servizio». La ministra imprenditrice ha anche ottenuto 2,7 milioni di euro di prestito dallo Stato (ma i suoi curatori spiegano che non lo rimborserà perché non ha i soldi) ma secondo l’inchiesta di Report ha pompato solo poco meno. E poi ancora Santranchè dice al Senato che la società fallita non è sua, ma si scopre che in realtà la controlla (con un patto para-sociale) e con il compagno dal nome creativo e persino suo figlio (con l’ex dipendente un po’ acida che ricorda: «Siccome non sapeva bene cosa fare chiamava la mamma al telefonino davanti a noi»).
Ecco, provate a immaginare cosa c’entra tutto questo con la Meloni. Poco o nulla. Ma adesso, la prima presidente donna, deve affrontare il primo virus misogino contratto dalla sua creatura politica. Qualunque scelta – sia parlare che tacere – come cantava il suo amato De André – è una ferita: «E per tutti/ il dolore degli altri/ è un dolore a metà».