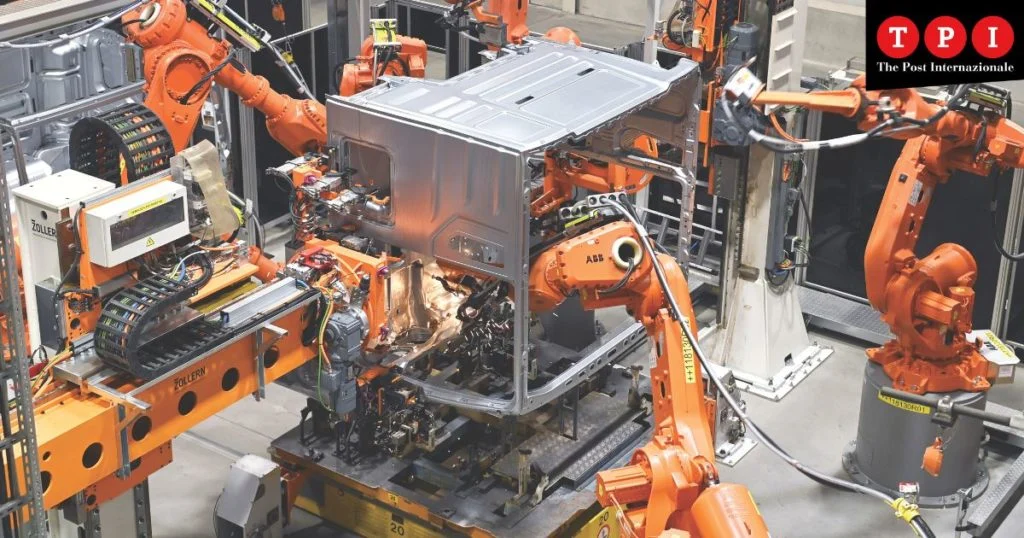«Il Ssn italiano, nato nel 1978 e che era l’orgoglio di questa nazione, venne istituito con la forte intenzione di fornire salute ai cittadini. Un’idea che oggi non esiste più. Ormai il Ssn è diventato soltanto erogatore di prestazioni e non guarda al totale delle necessità dei cittadini i cui bisogni di salute non vengono soddisfatti». A parlare è Fabio De Iaco, presidente nazionale della Simeu – Società Italiana Medicina di Emergenza Urgenza.
Il Servizio Sanitario Nazionale italiano è come un paziente malato per cui ad ogni ulteriore indagine emergono altre criticità. Dalla testa ai piedi questo “paziente” presenta problemi che non possono essere risolti se non con un imponente piano di investimenti da parte dello Stato. Ma nel Def non c’è alcuna svolta per la sanità. In pochi ormai speravano in un cambio di rotta ma adesso è certificato: l’Italia continuerà ad essere uno dei Paesi europei con il più basso rapporto percentuale tra spesa sanitaria pubblica e prodotto interno lordo. Significa che investe meno degli altri in questo settore fondamentale. Tra l’altro, secondo le stime dell’esecutivo, il dato è destinato a scendere nei prossimi anni.
Eppure, anche con un solo tuffo nella prima linea – i pronto soccorso – è possibile comprendere facilmente dove si annidino i problemi e cosa sarebbe importante fare prima di un tracollo totale del sistema.
Una coperta troppo corta
«Siamo in una fase di grande difficoltà per carenza organici. Dopo il Covid c’è stata un’accelerazione importante di un fenomeno che già esisteva prima ossia la fuga dei medici dal pubblico e in particolare dal pronto soccorso, che è il luogo in assoluto più disagevole», spiega De Iaco.
«Abbiamo un lavoro che è verosimilmente il più intenso e più gravoso dal punto di vista psicofisico dell’intero Ssn. La valorizzazione economica e professionale è uguale a qualunque tipo di lavoro del Ssn e accanto a questo c’è il disagio di un lavoro fortemente esposto da un punto di vista medico-legale perché ovviamente siamo al centro del vortice per i contenziosi e contemporaneamente abbiamo il problema del rapporto con un pubblico che spesso è esasperato dalla situazione. A fronte di tutto questo, quello che è accade è che la scelta di lavorare nel pubblico e nel Ps paga molto poco. In primis perché non abbiamo accesso alla libera professione intramuraria che invece è a disposizione della massima parte dei nostri colleghi. In secondo luogo, la valorizzazione economica è molto poca, recentemente ci è stata riconosciuta un’indennità di pronto soccorso con uno sforzo del Ssn, ma stiamo parlando di cifre che mensilmente viaggiano nell’ordine dei 100- 150 euro. Pur essendo importante il segnale, non fa molta differenza. E poi c’è il fenomeno delle cooperative, dei gettonisti che da privati vengono a fare il Ps. Si verifica così quello sbilanciamento per cui si ritrovano a lavorare fianco a fianco persone che si portano sulle spalle il peso di portare avanti la struttura con persone che vengono spot per fare un turno e andar via e vengono pagate 100 euro all’ora. Recentemente, è stato deciso al livello nazionale che le prestazioni aggiuntive vengano pagate anche per gli interni 100 euro all’ora però parliamo sempre di prestazioni aggiuntive, di turni in più rispetto a quello che è il carico di lavoro».
Questo è un primo preoccupante quadro descritto da De Iaco che conosce e vive in maniera approfondita le difficoltà di un mondo, quello del pronto soccorso ospedaliero, dove ogni mancanza pesa più che altrove.
«Esistono delle norme per ore e giorni di riposo in base alle prestazioni aggiuntive per i medici del Ssn, ma i colleghi delle cooperative possono permettersi di non seguire queste norme e quindi succede che noi cerchiamo di seguire queste regole e poi abbiamo colleghi che vengono a fare 3 notti consecutive. C’è un problema. Spesso poi il paradosso diventa pazzesco quando accanto a strutturati con 15 anni di esperienza lavorano neolaureati pagati lautamente che non hanno alcuna esperienza o competenza di Ps».
Il problema non è delle cooperative, ma di una coperta troppo corta per coprire tutte le esigenze. «Quando si è provato in tutti i modi a coprire i turni con gli interni senza successo, ci si rivolge alle cooperative. Ora sta succedendo che le cooperative non sono in grado di gestire tutte le richieste, quindi la corsa al rialzo diventa un’asta sui turni per cui vince l’azienda che si può permettere di pagare di più. Il Governo sta provando a mettere un tappo, è uscito il Dl 34/2020 convertito con la legge 56 che va in questo senso. Ma comunque resta il problema perché anche mettendo un freno è evidente che le cooperative coprono un vuoto che in alternativa resta».
L’altro punto, dopo gli organici, è quello che riguarda le richieste che vengono fatte al pronto soccorso. «Premesso che gestiamo cose e pazienti che potrebbero e dovrebbero essere seguiti dal territorio, dalla medicina generale, il vero punto è che stiamo assistendo progressivamente a un aumento costante di attesa di ricovero in pronto soccorso. Ormai all’interno di tantissimi pronto soccorso italiani abbiamo interi reparti fantasma: 20, 30, anche 40 pazienti in attesa di ricovero per periodi che vanno dalle 24 ore fino a 7 giorni e tutti quei pazienti devono essere gestiti dalle stesse persone che fanno il Ps. A inizio anno calcolavamo che mancano circa 5mila medici di pronto soccorso in Italia e adesso sono aumentati. Quindi l’organico diminuisce e il carico di lavoro continua ad aumentare. Tutto questo configura una situazione insostenibile».
Mancano i medici, mancano i soldi, manca un solido sistema socio-assistenziale in grado di assistere quei malati che potrebbero essere curati a domicilio e mancano strutture e posti letto. Così come ci ha dimostrato il Covid.
In eterna emergenza
Più volte abbiamo trattato le lacune del sistema sanitario nazionale in questi due anni di emergenza. Un’assistenza tramortita da anni di tagli alla spesa non invertita nemmeno nell’ultimo biennio. Ora vediamo invece come si è mosso il Paese in merito ai posti di terapia intensiva disponibili, la cui scarsità aveva comportato molti problemi (e probabilmente contribuito ad aumentare il numero di morti) nelle prime fasi dell’emergenza. Si scopre così che in questo ambito l’Italia se l’è complessivamente cavata, seppur vi siano notevoli disparità tra le regioni ed in alcune di esse i posti letto a disposizione non raggiungano lo standard minimo imposto dalla normativa di riferimento.
La pandemia ha evidenziato come uno dei principali punti di debolezza del nostro sistema ospedaliero sia rappresentato dalla pressione esercitata in alcune fasi dai ricoveri in terapia intensiva.
Nella prima fase dell’emergenza, quello in cui si è raggiunto il picco più alto con 3.944 casi il 4 aprile 2020, si sono adottate tutte le possibili soluzioni provvisorie dall’utilizzo delle sale operatorie alla creazione di spazi esterni, fino alle due Fiere adattate a terapia intensiva di Milano e Civitanova Marche.
A questa criticità in termini strutturali si è data risposta con il DL 34/2020 che ha previsto un incremento dei posti letto sia di terapia intensiva che semi-intensiva. In base alle linee di indirizzo ministeriali per l’applicazione del Decreto ne sono stati previsti 3.500 in più di intensiva (in modo da arrivare a 8.679) e 4.225 in più di semi-intensiva. Pur in presenza di ritardi nella realizzazione di questi posti letto aggiuntivi, le Regioni sono in qualche modo riuscite ad arrivare, secondo ill Report Agenas sui ricoveri ospedalieri per Covid, a 9.538 posti attivi più 571 attivabili. Difficile attualmente stabilire quanto siano effettivamente attuabili questi posti letto.
Quello che sappiamo però è che le cose non sono andate come previsto dal Decreto in molte regioni. Per fare un esempio, in Calabria, era stato stilato un programma di implementazione dei posti letto di terapia intensiva e di terapia semi-intensiva. Inoltre era stata prevista, in ogni ospedale della regione, la realizzazione, previo stanziamento di 52 milioni di euro, di un Pronto soccorso dedicato Covid con annessa risonanza magnetica e Tac. In terapia intensiva era stata programmata una implementazione di 134 posti; in terapia semi-intensiva l’implementazione prevedeva ulteriori 136 letti; per i Pronto soccorso erano stati previsti 18 interventi. Infine si prevedeva l’acquisto di altre 9 ambulanze. Questa era la contabilità preventiva. Bene.
A distanza di oltre 3 anni qual è lo stato dell’arte? In terapia intensiva, anziché 134 posti, ne sono stati realizzati solo 24; in terapia semi-intensiva, a fronte di 136 posti, ne sono stati attivati appena 11; è stato realizzato un solo pronto soccorso Covid e sono state acquistate 6 ambulanze. Detto in altri termini, l’implementazione, in terapia intensiva, è pari appena al 18%.
Cala, vertiginosamente, in terapia semi-intensiva, attestandosi a un risibile 8%; crolla, disastrosamente, al 5% per la realizzazione dei Pronto soccorso Covid. L’attuazione del piano è miseramente fallita. Accanto a questi dati emergono delle criticità: i picchi di attività Covid (o di future altre malattie infettive respiratorie) delle terapie intensive non possono essere gestiti dal personale specializzato in servizio oggi disponibile senza sottrarlo alle altre attività sia urgenti che programmate; in ogni caso non ci sarà mai personale specializzato strutturato in servizio in quantità tale da poter far fronte a picchi di questa intensità e durata senza incidere pesantemente sulle altre attività.
Il grande buco
Partendo da un dato di base, possiamo analizzare il numero di infermieri in Italia. Secondo la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), il numero di infermieri attivi iscritti all’albo in Italia è di circa 395mila. Di questi, 270mila sono dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), 45mila sono professionisti autonomi e 80mila lavorano per strutture private.
In base all’ultimo rapporto Health at a Glance: Europe 2022, pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), in collaborazione con la Commissione Europea, nel 2020 in Italia c’erano 6,3 infermieri ogni 1.000 abitanti, rispetto a una media di 8,3 negli altri Paesi dell’Unione Europea. All’interno del personale sanitario la proporzione era di 1,6 infermieri ogni medico in Italia, rispetto alla media europea di 2,2.
Nel corso degli anni molte associazioni di categoria e istituti hanno cercato di quantificare il numero di infermieri mancanti in Italia. Secondo la Fnopi, servirebbero circa 63.500 infermieri in più rispetto a quelli attuali, con 27mila infermieri mancanti al Nord, circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole. Il Censis, istituto di ricerca socio-economica, ha calcolato una carenza di 57mila unità nel personale infermieristico. La Fnopi ha spiegato che la stima dei 63mila infermieri mancanti è stata calcolata sulla base di diversi dati, tra cui quelli raccolti dall’Ocse nell’Health at a Glance 2021, il rapporto che valuta la situazione sanitaria dei 38 Paesi dell’organizzazione.
Anche la Corte dei Conti ha commentato il tema, esprimendosi sulla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022 (Nadef), approvata dal Governo Draghi lo scorso settembre. Secondo la Corte dei Conti, il personale infermieristico italiano è «pesantemente sottodimensionato» in molte aree del Paese, soprattutto se confrontato con la situazione in altri Stati europei. L’analisi prende in considerazione lo «standard internazionale 1:3 per il personale infermieristico». Il che significa che per ogni medico attivo ci dovrebbero essere almeno tre infermieri attivi. Sulla base dei dati contenuti nell’Annuario Statistico dell’Istat, la Corte dei Conti ha calcolato una carenza di infermieri di circa 65mila unità nel 2020.
Tuttavia, è importante sottolineare che, quando si confrontano i dati a livello internazionale, si fa riferimento a sistemi sanitari molto diversi tra loro. Per esempio, la sanità italiana è molto diversa da quella degli Stati Uniti, dove il rapporto tra infermieri e popolazione è molto alto, ma non esiste un sistema sanitario pubblico universalistico, dove lo Stato copre gran parte delle cure mediche dei cittadini.
I fondi del Pnrr – In aggiunta alle carenze di personale infermieristico segnalate da diversi studi, anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede l’incremento del personale sanitario nei prossimi anni. La Missione 6 del Piano riguarda la riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, in cui gli infermieri avranno un ruolo fondamentale nell’assistenza domiciliare e nei servizi di consultorio familiare, e soprattutto nella nuova figura dell’infermiere di famiglia e comunità.
Quest’ultimo è descritto come il professionista di riferimento che collabora con gli altri professionisti presenti nella comunità. Il Pnrr richiede la presenza di almeno un infermiere di famiglia e comunità ogni 3mila abitanti. Ma, ed è questo il grande “ma”, saranno necessarie circa 30mila nuove assunzioni di infermieri nei prossimi tre anni per soddisfare le aspettative del Piano.