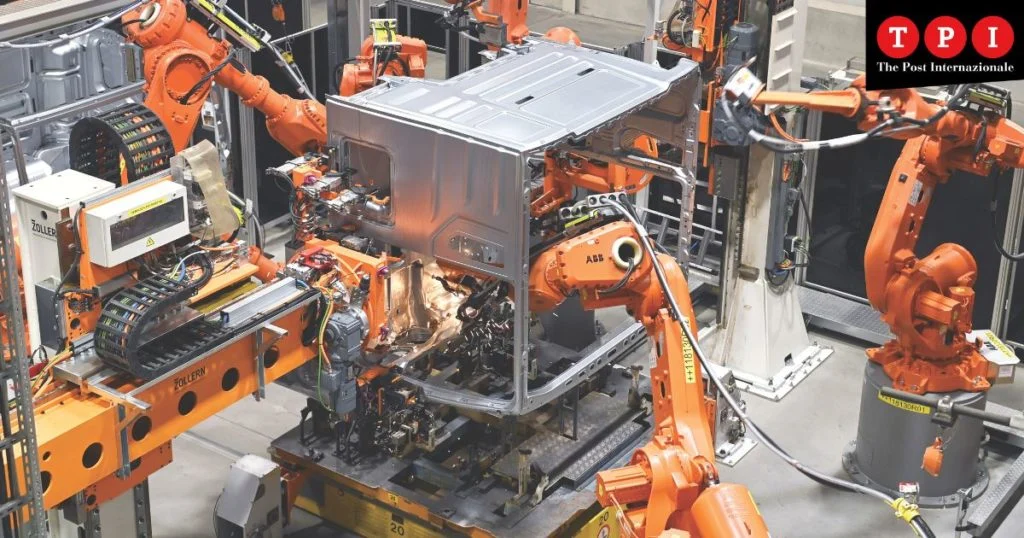Aprire un ristorante, riuscire a terminare gli studi o gestire un negozio di prodotti tessili che le renda economicamente indipendenti, in modo da mantenere le proprie famiglie. Sono solo alcuni dei sogni delle donne liberate dalle carceri di El Salvador, uno dei Paesi dove l’aborto è classificato, secondo il codice penale del 1998, come omicidio aggravato, sempre e comunque. Tra di loro Teodora, Katya, Zuleyma ed Ena hanno trascorso quasi un decennio dietro le sbarre, dopo aver sofferto di emergenze ostetriche o aborti spontanei ed essere state condannate a pene che vanno dai venti ai trent’anni di carcere.
«Nei nostri casi e in quelli delle altre detenute, si condanna la povertà e la mancanza di conoscenza, l’essere donne che vivono in aree rurali, lontane dai servizi medici», spiega Teodora Vásquez. Madre single di 39 anni con un figlio di quasi vent’anni, che ha trascorso quasi un decennio nel sovraffollato carcere salvadoregno di Ilopango, tra violenza e discriminazioni.
Una battaglia continentale
In America Latina, l’aborto è proibito in qualsiasi circostanza in cinque Paesi: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana e Haiti. In Guatemala, Messico, Panama, Paraguay e Venezuela è invece consentito solo se la donna è in pericolo di vita. Nel resto del continente le condizioni variano a seconda delle diverse causali permesse, ma negli ultimi anni, grazie all’attivismo dei movimenti femministi sono state conseguite importanti vittorie. L’ultima in Colombia, dove dal febbraio 2022 l’interruzione volontaria di gravidanza è stata depenalizzata entro le ventiquattro settimane di gestazione, una delle condizioni più permissive al mondo. O ancora in Argentina, dove nel 2020, dopo anni di mobilitazioni di piazza con il movimento della “Marea Verde” si è conquistato il diritto all’aborto fino quattordicesima settimana di gestazione e oltre questo termine, in caso di violenza sessuale o pericolo per la salute della gestante.
E le lotte vanno avanti in tutto il continente, anche in El Salvador. Durante gli anni di reclusione, Teodora si è convertita in attivista per dare voce alle donne incarcerate, attraverso il lavoro dell’associazione “Mujeres Libres”, che ha fondato proprio per questo scopo. La donna era stata arrestata nel 2007, a seguito di un aborto spontaneo avvenuto al nono mese di gravidanza. Aveva 22 anni e lavorava in una scuola quando improvvisamente iniziò a sentire dei dolori simili a quelli del parto. Prima di svenire è riuscita a chiamare un’ambulanza, che però è arrivata dopo molto tempo. Al suo risveglio il bambino era morto e i medici l’avevano denunciata.
«Non avrei mai immaginato che mi sarebbe potuto capitare qualcosa di simile. L’unica alternativa per reagire a questa ingiustizia è stata quella di unirci e fare rumore dall’interno del carcere. Abbiamo così iniziato una mobilitazione giuridica e sociale per la liberazione delle donne incarcerate come me. In quel momento eravamo diciassette», continua Vásquez. «Ma fino a quando non ci sarà un cambio legislativo, storie come le nostre continueranno purtroppo a ripetersi, soprattutto alle donne più povere e vulnerabili. Chi può permettersi le cure non finisce in carcere perché se hanno problemi ostetrici non chiamano l’ambulanza o non si rivolgono al servizio pubblico, ma si affidano alle cliniche private dove vengono curate e non denunciate».
A norma di legge
Durante la detenzione nel carcere di Ilopango, Teodora ha conosciuto Ena Munguía Alvarado, 40 anni, originaria del villaggio di Cojutepeque, a venti chilometri dalla capitale El Salvador. Ena ha sofferto un aborto spontaneo al settimo mese di gravidanza, quando aspettava il suo quinto figlio. Quando aveva iniziato a sentirsi male, Ena si era recata nella latrina, visto che nel villaggio in cui risiedeva non c’erano (e tuttora non ci sono) altri servizi igienici. Al risveglio in ospedale, il bimbo, Ervin Alexander si era salvato ed era ancora vivo. «Sono arrivata in ospedale in stato di incoscienza», spiega Ena. «Nonostante mio figlio fosse sopravvissuto, i medici mi dissero che non me ne sarei potuta andare a casa. Così è stato: ho trascorso più di nove anni in carcere, anche se la mia condanna ammontava a trenta, ridotta poi a quindici visto che Ervin si era salvato». Ena non ha potuto vedere il suo bimbo fino a quando non ha compiuto tre anni. «Adesso ne ha 14 e abbiamo recuperato un bel rapporto, nonostante tutti gli anni di separazione».
Diversa la storia di Zuleyma Beltrán, anche lei parte dell’associazione presieduta da Teodora. La donna, 40enne, ha subito un aborto spontaneo al settimo mese di gravidanza ma il suo bebè non è sopravvissuto. «Avevo un forte dolore di stomaco», racconta Zuleyma. «Mi sono svegliata in ospedale dopo che mio fratello aveva chiamato un’ambulanza. Nessuno dei due conosceva questa legge, non ci saremmo mai immaginati che sarei finita in carcere. Sono stata la prima del mio villaggio ad andare dentro per questo motivo». Zuleyma ha trascorso dieci anni dietro le sbarre, a fronte di una condanna di ventisei.
Ammontava invece a ventotto anni la condanna di Katya Amanda Araujo, 37 anni, dei quali otto e mezzo trascorsi nel carcere di San Miguel. «Come le altre sono stata accusata di omicidio aggravato. Per tanto tempo ho accettato la pena perché mi sentivo effettivamente responsabile. Pensavo che se avessi chiamato prima i soccorsi il mio bambino si sarebbe potuto salvare, che avrei dovuto comportarmi in maniera diversa. Solo grazie al sostegno psicologico che ho ricevuto da Mujeres Libres e da altre associazioni mi sono resa conto che non è stata colpa mia. Oggi sono determinata a educare l’altra mia figlia, già adolescente, ad una sessualità consapevole. Voglio fornirle gli strumenti per evitare che possa finire vittima di violenza domestica o in generale del machismo diffuso nel nostro Paese».
Adesso Katya ha ripreso gli studi, interrotti con l’arresto, ma il percorso per superare il trauma dei suoi oltre otto anni carcere è ancora lungo. La detenzione è ricordata come un periodo estremamente doloroso da tutte le attiviste, soprattutto per le condizioni di vita carceraria, ma anche per le varie forme di discriminazione che subiscono le donne criminalizzate per emergenze ostetriche. «Sono stata emarginata per il mio “delitto”», prosegue Katy. «Quando sono arrivata tutte conoscevano il motivo del mio arresto. La polizia mi aveva messo contro tutte le altre detenute, che mi discriminavano, aggredivano e mi chiamavano “mataniños” (assassina di bambini, ndr). Una volta, pochi giorni dopo il mio arrivo in carcere, mi circondarono per picchiarmi.
Violenza di sistema
La stigmatizzazione sociale delle donne che vivono emergenze ostetriche o aborti spontanei è frequente e avviene in un sistema permeato dalla violenza domestica: secondo la ong salvadoregna Ormusa, che analizza i numeri della violenza maschilista nel Paese, si registrano oltre tre casi ogni giorno in una nazione di circa 6milioni e 300mila abitanti. Si tratta di violenze che, come spiegano le attiviste, in molti casi sono la causa stessa degli aborti spontanei, che poi le donne pagano con anni di carcere. «La violenza contro le donne in El Salvador è consentita, è tollerata, a volte incoraggiata, e nella maggior parte dei casi rimane impunita», spiega l’esperta Morena Herrera, filosofa e attivista per i diritti delle donne. «Non c’è punizione per chi la perpetra. La violenza si basa sulla stessa cultura patriarcale che non valorizza la vita delle donne e che tollera l’abuso sessuale contro ragazze e adolescenti».
Criminalizzare le donne che subiscono emergenze ostetriche è quindi solo parte di un disegno più ampio. «Si scontrano», prosegue l’esperta, «con la società salvadoregna che è molto patriarcale, altamente conservatrice e classista. In primo luogo si tratta di donne che vivono in condizioni di povertà e questo genera di per sé una situazione di discriminazione, in quanto si pensa che non vogliono le creature che portano nel ventre perché non possono mantenerle. Però lo stigma va ben oltre. Si mette in discussione che si siano ribellate contro il mandato della maternità: in El Salvador, come in altre società, essere madri è associato in termini identitari ad essere donne».
L’esperta aggiunge che la criminalizzazione è generata da diversi settori, infatti, le denunce sono presentate dal personale sanitario, dai medici, dai portieri, dalle infermiere ma anche dai poliziotti e dai giudici. «In molti casi prevale l’idea che la donna sia colpevole nonostante non ci siano prove dirette. In questo modo la giudicano e la condannano senza appello», conclude Herrera.
Senza adeguate difese
Le attiviste ormai lottano da decenni contro questo sistema, grazie all’appoggio dei collettivi femministi, del Centro di Diritti Riproduttivi (CRR) e di una coalizione di organizzazioni guidata dalla Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, che dal 2009 lotta per promuovere un cambio legislativo, per tutelare le donne criminalizzate e fomentare un cambio di mentalità sociale sul tema dell’aborto nel Paese. Grazie a diverse strategie di appoggio legale sono riuscite negli anni a tirare fuori dalle carceri 69 donne, tra cui proprio Teodora, Katya, Zuleyma ed Ena. Infatti, le quattro attiviste sono tra i 181 casi registrati di emergenze ostetriche avvenuti nel Paese tra il 2000 e il 2019.
«Nella maggior parte dei casi quello che manca è una difesa adeguata», spiega Alejandra Coll, che lavora come consulente legale del Centro di Diritti Riproduttivi (CRR), una delle organizzazioni impegnate per la difesa dell’autonomia riproduttiva in tutto il mondo. «Alle donne viene assegnato un avvocato di ufficio e non vengono tenute informate di tutte le fasi processuali. Si gioca molto sull’ignoranza. Il nostro obiettivo principale è quello di cambiare la legge, ma in questa fase ci stiamo anche impegnando a far sì che le donne criminalizzate ingiustamente possano uscire dal carcere come innocenti. Non avere precedenti penali le aiuta al momento di trovare un lavoro o una casa». A queste battaglie si aggiunge quella sul segreto professionale per i medici. «C’è un articolo specifico della legge che sanziona il personale sanitario che non denuncia. Per questo se hanno un qualsiasi sospetto preferiscono denunciare per non rischiare loro stessi».
L’attivismo del Centro e delle organizzazioni sta segnando importanti vittorie. Lo scorso novembre si è festeggiato l’anniversario della storica decisione presa dalla Corte Internazionale dei Diritti Umani che aveva condannato lo Stato de El Salvador per il caso Manuela. Una donna condannata a 30 anni di carcere a seguito di un’emergenza ostetrica. A causa di un cancro linfatico non diagnosticato e di una caduta mentre raccoglieva acqua al fiume vicino casa, Manuela ha avuto un’interruzione spontanea della sua gravidanza ed è stata denunciata dal personale medico, che anche in questo caso, è venuto meno al segreto professionale. Manuela è morta in carcere, lasciando i suoi due figli di 7 e 9 anni, dopo essere stata detenuta in condizioni disumane, senza le cure per la malattia cronica di cui soffriva. Nonostante la sentenza che ha riconosciuto il segreto professionale del personale medico come fondamentale, lo Stato non ha ancora messo in pratica le richieste della Corte. Inoltre, si tratta di una sentenza che ha creato un precedente nel Paese per evitare l’attuazione degli stereotipi di genere nella giurisprudenza e garantire una gestione adeguata delle emergenze ostetriche in termini di servizi sanitari.
Un altro passo si è compiuto il 23 marzo 2023, quando la Corte interamericana dei diritti umani ha tenuto la prima udienza nel caso noto come Beatriz contro El Salvador, affrontando così per la prima volta il divieto totale dell’aborto nelle Americhe. La sentenza, attesa per l’autunno, potrebbe avere ripercussioni su El Salvador e sull’intera regione.
Ma non è finita
Attualmente due donne sono ancora nelle carceri salvadoregne mentre altre due sono coinvolte in processi che presentano errori e mancanze simili a quelli denunciati nel caso di Manuela. Questi sono però solo i casi conosciuti dalle varie organizzazioni, che ammettono che potrebbero essere molti di più.
In tutto questo, le attiviste come Teodora e i collettivi continuano la lotta con gruppi femministi nazionali e internazionali, tra cui l’Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto. «Lavoriamo in tre direzioni: promuovere la libertà delle donne, fomentare il cambio degli immaginari sociali in relazione all’aborto e cambiare la legge», spiega la coordinatrice Sara García. «Facciamo un lavoro politico femminista con le compagne del Centro e Sudamerica perché crediamo che sia fondamentale lavorare in rete. Allo stesso tempo cerchiamo, da un punto di vista legale, di promuovere diverse strategie: revisione delle sentenze, commutazione delle pene, indulto e risarcimenti totali per le donne che sono state criminalizzate ingiustamente».
Una lotta che porta le attiviste a continuare con il loro impegno per cambiare la legge. Sognano di liberare tutte le donne incarcerate per emergenze ostetriche, molte delle quali non sono state ancora identificate nelle diverse carceri del Paese, ma anche offrire supporto psicologico, lavorativo, giuridico per accompagnarle nel percorso di ritorno alla libertà e il reinserimento nella società.
Nel frattempo Teodora, Katy, Zuleyma ed Ena vivono insieme in una casa nella città de El Salvador affittata dalla loro associazione. Lì ospitano spesso altre donne che hanno vissuto le stesse esperienze e che vengono nella capitale per risolvere questioni giuridiche, amministrative, o per cercare di riprendere in mano le proprie vite. Lavorano instancabilmente per far conoscere le loro storie, specialmente nelle zone rurali, grazie alla realizzazione di un programma radiofonico, di un documentario, che ha proprio Teodora come protagonista, e di un’opera teatrale. «L’idea – spiegano – è quella di arrivare anche alle adolescenti, che abitano nei villaggi più distanti e che non conoscendo questa legge e non avendo nessun elemento di educazione sessuale, potrebbero essere potenziali vittime».
Due sono quindi le direzioni. «Vogliamo lavorare per superare il trauma della detenzione», conclude Teodora. «E dare potere alle donne che sono state criminalizzate ingiustamente, ma allo stesso tempo ci impegniamo affinché nel prossimo futuro nessuna finisca più in carcere dopo aver sofferto di emergenze ostetriche».