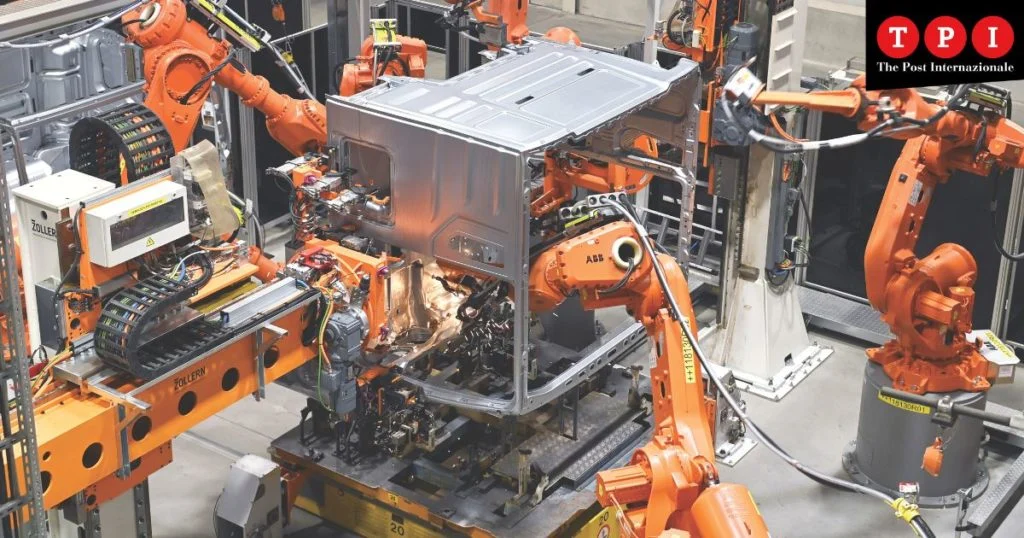Un maiale si aggira per le strade di Bruxelles, sfuggito forse a una manifestazione di protesta degli allevatori. Corre, qualcuno lo nota, molti no. Vero o immaginario che sia, riesce a suscitare qualche simpatia ma tra alcuni semina il panico. L’incipit del romanzo di Robert Menasse “La capitale”, ironica e polifonica descrizione della Babele nel cuore politico dell’Unione europea, sembra perfetta per illustrare il recente tentativo della Commissione Ue di conquistarsi nuove “risorse proprie”, indipendenti dai contributi degli Stati membri. Guai però a chiamarle tasse!
Pochi capiscono da dove arrivano (e dove finiranno) queste risorse, tanti sperano sia un ulteriore passo avanti in grado di svincolare l’Unione dal peso degli opposti interessi nazionali, mentre altri temono di dare vita a un mostro incontrollabile, che nel lungo periodo toglierà potere, denaro e sovranità proprio agli Stati nazionali, gravando cittadini e imprese di ulteriori oneri.
Tutto è cominciato dopo la pandemia, quando l’esecutivo comunitario propose di inserire tra le attuali entrate del bilancio Ue tre nuove fonti, a cui il 20 giugno scorso se n’è aggiunta una quarta.
L’obiettivo è ridurre i contributi degli Stati membri, dotando l’Unione di risorse proprie che coprano i maggiori costi legati al debito straordinario contratto per il Recovery e finanzino i recenti impegni internazionali (vedi le polemiche sugli ulteriori aiuti all’Ucraina, circa 50 miliardi), agendo però solo su strumenti di regolamentazione, senza nuove imposte. Anche perché queste ultime richiederebbero il consenso politico unanime dei diversi Paesi, che è esattamente il problema che si vuole superare.
Un sistema non abbastanza redditizio
Ma facciamo un passo indietro e vediamo com’è attualmente finanziato il bilancio dell’Ue, che per il 2021-2027 prevede una dotazione di oltre 2.000 miliardi di euro (1.211 di quadro finanziario pluriennale e 806,9 per il programma Next Generation EU, il famoso Recovery). Si tratta sostanzialmente di un tetto massimo di spesa che, a causa del piano di ripresa dalla pandemia, con l’attuale quadro settennale di finanziamento è passato da una media dell’1 a ormai quasi il 2,4% del Pil degli Stati membri. Fondi che, per coprire le spese programmate, in qualche modo devono essere trovati. «Al di là della deroga stabilita per il Next Generation EU, secondo il principio della parità di bilancio, l’Unione non può fare debito», ci spiega una fonte interna alla Commissione europea. «Quindi le entrate che finanziano il budget sono determinate sulla base di quanto l’Ue programma di spendere e per cosa».
Attualmente il 90% delle risorse proprie dell’Unione arriva da quattro fonti principali: dazi doganali, quote dell’Iva, proventi della cosiddetta Plastic Tax e versamenti dei 27 Stati membri, il cui contributo pro-quota si basa sul rispettivo Reddito nazionale lordo (con riduzioni forfettarie applicabili ad Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia).
«Bisogna distinguere tra risorse tradizionali, Iva e contributi degli Stati membri», ci spiega il funzionario dell’Ue. «Le risorse tradizionali riguardano i dazi doganali e i prelievi agricoli». Come spiega la Commissione, i dazi sulle importazioni sono riscossi alle frontiere esterne dell’Ue, da cui gli Stati membri trattengono il 25% a titolo di rimborso per spese di esazione, mentre l’Unione ha diritto a un prelievo sulla produzione di zucchero. «Di fatto, sono delle vere e proprie tasse, pagate dagli operatori economici (gli importatori e i produttori agricoli, ndr)», ammette la nostra fonte nella Commissione.
Discorso diverso per l’Iva. «È stata strutturata come un contributo nazionale, nel senso che è lo Stato membro a versare all’Ue una quota fissa dell’imposta riscossa dai contribuenti», sottolinea il funzionario dell’esecutivo comunitario. «A differenza di quanto accade con i dazi, a partire da tutto quello che viene incamerato in termini di Iva dal Paese membro – con una formula uguale per ogni Stato – si calcola una base imponibile comune e ogni mese l’1% di questa viene messo a disposizione dell’Unione». A queste risorse si aggiunge poi un’altra fonte di finanziamento legata alla quantità di rifiuti generati a livello nazionale dagli imballaggi in plastica non riciclata, a cui i vari Paesi contribuiscono con 80 centesimi di euro per chilogrammo (la famosa Plastic tax, che dovrebbe scoraggiare l’uso di materiali non riciclabili).
Chi paga e quanto
Tuttavia dipende ancora tutto dagli Stati perché non esiste un prelievo fiscale diretto a livello europeo, come ci spiega il professor Pasquale Pistone, presidente accademico dell’International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam. «Tutti i tributi sono comunque amministrati a livello nazionale, una parte del loro gettito va all’Ue ma dipende sempre dai Paesi membri, che agiscono da collettori», ricorda l’esperto di diritto tributario europeo. «D’altronde, allo stato attuale, è difficile immaginare qualcosa di diverso, perché l’Unione non ha una capacità autonoma di riscossione e duplicare i sistemi nazionali con uno comunitario rischierebbe di risultare inefficiente». «I dazi, ad esempio», ci spiega la nostra fonte alla Commissione, «sono riscossi dalle varie dogane nazionali. Ogni mese, tolto il 25% trattenuto dallo Stato membro, la somma viene accreditata presso il conto aperto dalla Commissione in quel Paese».
A prescindere da chi le riscuota però, il problema è che rendono poco. «Le risorse tradizionali sono piuttosto limitate: l’Ue è il campione della globalizzazione, quindi i dazi non fruttano molto anche perché non servono tanto a fare cassa ma più che altro ad implementare una politica economica improntata al libero scambio», osserva la nostra fonte della Commissione europea. «D’altra parte, i prelievi sullo zucchero sono poi comunque utilizzati per finanziare i sussidi all’agricoltura, quindi è una partita di giro. Mentre lo scopo della Plastic tax è idealmente eliminare la plastica non riciclata quindi prima o poi è destinata ad azzerarsi».
Come fa allora l’Unione a essere finanziariamente autonoma? Con la “risorsa residuale” proveniente dai Paesi membri. «La particolarità è che sono tutte entrate garantite», ricorda la nostra fonte europea. «Nel senso che i contributi degli Stati nazionali compensano tutte le spese non coperte dalle altre risorse».
È qui il cuore del problema: ci sono Stati che contribuiscono più di altri – perché più ricchi – e che poi percepiscono meno fondi europei. Per cui hanno cominciato a chiedere sconti e riduzioni, forti delle regole contenute nei Trattati. «Per le decisioni in materia finanziaria non solo è necessaria l’unanimità di tutti i Paesi ma anche l’approvazione dei singoli Parlamenti, ciascuno secondo le tradizioni costituzionali nazionali», prosegue il funzionario Ue.
Il principio dell’unanimità poi, aggiungiamo noi, è diventato anche un’arma di ricatto in mano ai singoli Governi, da usare a piacimento per ottenere vantaggi anche su altri dossier. Perciò, le istituzioni dell’Ue hanno sentito il bisogno di ridurre la propria dipendenza dai contributi nazionali, puntando su altre risorse.
Obiettivo: autonomia
Così il nuovo pacchetto di proposte varato il 20 giugno scorso, che dovrà prima essere approvato dagli Stati membri, delinea altre quattro fonti di entrata, tutte attinenti a strumenti di regolamentazione del mercato che prevedono solo prelievi indiretti perché, come tiene a precisare la Commissione, l’Ue non è interessata a creare nuove imposte.
La prima prevede un’aliquota del 30% sui proventi generati dalle aste organizzate nell’ambito del Sistema di scambio di quote di emissione (Emission Trading System, Ets), che da anni obbliga migliaia di centrali elettriche e fabbriche dell’Ue a richiedere un permesso (e pagare) per ogni tonnellata di CO2 emessa, secondo il principio chi meno inquina, meno paga. La seconda invece contempla l’assegnazione al bilancio comunitario del 75% delle entrate del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, Cbam), che sarà implementato nei prossimi anni imponendo un sovrapprezzo ai produttori extraeuropei che non rispettano le regole ecologiche in vigore nell’Ue (es. l’acciaio importato dalla Cina), al duplice scopo di tutelare l’ambiente e combattere la concorrenza sleale. Entrambe le misure, secondo gli esperti, sarebbero paragonabili al funzionamento del sistema dei dazi. Discorso diverso invece per le ultime due, legate al mondo delle imprese, con un’avvertenza da parte di Bruxelles: non si tratta di imposte societarie.
La terza risorsa proposta si basa sulla quota di utili residui delle multinazionali riassegnata agli Stati nell’ambito dell’accordo Ocse-G20 – non ancora implementato – sui diritti di imposizione. «Il suo funzionamento dovrebbe ispirarsi a quello dell’Iva, con un versamento da parte degli Stati membri di una quota fissa della base imponibile armonizzata sugli extra-profitti delle multinazionali. L’obiettivo è creare un livello di tassazione minima ma è qualcosa ancora da definire», afferma la nostra fonte alla Commissione.
È comunque un passo importante, come sottolinea il professor Pistone. «Sebbene sia lontano dall’applicazione perché richiederebbe un’implementazione globale, riconosce il collegamento all’imposizione nel cosiddetto Stato del mercato», ci spiega l’accademico. «Prima compravamo i cd di musica nei negozi fisici, mentre ora scarichiamo i brani online. L’acquisto in negozio giustificava l’esigibilità dell’imposta sul profitto nel Paese in cui si trovava il punto vendita. La smaterializzazione però ha cambiato tutto e così le multinazionali digitali si trovano a contribuire molto meno rispetto alle industrie tradizionali. L’accordo riconosce invece la potestà impositiva sugli utili d’impresa da parte dello Stato in cui si trova chi scarica la musica». «Per ora però siamo solo alle dichiarazioni di principio», sottolinea la nostra fonte alla Commissione.
Contro il dumping fiscale
Se su quest’ultimo punto siamo ancora in alto mare, la quarta risorsa proposta invece promette un’applicazione più semplice, basandosi sulle statistiche relative agli utili aziendali su cui poi calcolare ulteriori contributi dai Paesi membri.
«Dovrebbe funzionare come la Plastic Tax, un vero e proprio contributo che ogni Stato dovrebbe pagare sulla base dei dati statistici aziendali», ci rivela la nostra fonte. «Esiste un regolamento europeo che stabilisce i criteri con cui ogni Paese deve presentare la contabilità nazionale, tra cui quanto producono le imprese e quali sono i loro profitti. Quindi il dato contabile esiste già, basta solo fissare la formula con cui calcolare il contributo».
La sua finalità è finanziare il bilancio Ue in maniera più equa, finendo anche per contrastare il dumping fiscale. «È concepita come una sorta di compensazione verso quegli Stati da cui le imprese si spostano per approdare in Paesi membri con livelli di tassazione più favorevoli», ci spiega la fonte della Commissione europea. «Siccome si calcola sui dati statistici relativi alla produzione e ai profitti delle imprese, gli Stati che attraggono più investimenti grazie a una fiscalità di favore contribuiranno di più».
La misura però non dovrebbe restare in vigore per sempre. «È temporanea e servirà per coprire i maggiori costi del debito comune contratto in via straordinaria per finanziare il NextGenEU, spese legate all’aumento dei tassi della Bce per contrastare l’inflazione», aggiunge la nostra fonte. «Sarà sostituita prima o poi dalla risorsa “Business in Europe: Framework for Income Taxation (Befit)”, un corpus unico di norme sulla tassazione societaria, mirante a un’armonizzazione della base imponibile nell’Ue e alla riscossione delle imposte dagli operatori che accedono al mercato unico». Qualcosa di simile, prosegue, alle misure fiscali in vigore a livello nazionale ma che per ora è ancora molto lontana.
Imposizione comune?
Al di là degli aspetti più tecnici, parliamo comunque di cifre importanti: secondo le previsioni della Commissione, ai prezzi del 2018, complessivamente questo pacchetto dovrebbe fornire al bilancio comunitario una media di 36 miliardi di euro all’anno a partire dal 2028, una cifra quasi pari ai versamenti annui della Germania, il principale Paese contributore dell’Ue. «Sarebbe un grosso passo avanti rispetto alla grave dipendenza dai trasferimenti da parte degli Stati», sottolinea il professor Pistone. «Un processo certamente positivo verso un rafforzamento, per così dire, dell’autonomia finanziaria dell’Ue. Rendere meno dipendente il bilancio comunitario dai contributi degli Stati membri basati sul Pil nazionale a favore di fonti più dirette di finanziamento è sicuramente virtuoso, perché va verso una maggiore trasparenza tra il prelievo e la destinazione delle risorse».
Tuttavia, per ora, la mancanza di una politica fiscale comunitaria impedisce una tassazione europea che finanzi interventi comuni. «I problemi europei richiedono risposte europee», rimarca Pistone. «Ma per ogni misura in materia fiscale è previsto il requisito dell’unanimità degli Stati membri, che spesso blocca ogni decisione». Così, forse, si spiega la ripetuta notazione della Commissione, che precisa di non voler “proporre imposte europee”.
«È un timore comune all’interno della Commissione Ue», osserva la nostra fonte presso l’esecutivo comunitario. «La paura di chiamarle imposte è legata alla percezione negativa nell’opinione pubblica di una tassazione europea. È una foglia di fico perché l’Ue funziona, offre sussidi, amministra il mercato Ets, promuove lo sviluppo, finanzia Frontex e il programma satellitare Galileo, aiuta l’Ucraina, etc. Non può certo operare gratuitamente. Ma la paura dell’opinione pubblica è troppo forte e così li chiamano “meccanismi” ma sono misure fiscali».
Insomma, le “tasse” europee esistono già e (forse) ne creeremo anche di nuove ma (per ora) non bisogna chiamarle così. «In genere si distingue tra tributi con fini fiscali, il cui obiettivo è creare gettito, e tributi con fini extrafiscali, volti ad altri scopi come ad esempio la tutela ambientale, lo sviluppo economico, etc», spiega Pistone. «Tuttavia, pur avendo nominalmente altre finalità, tali strumenti creano comunque gettito e quindi sono misure di natura tributaria». Anche se la Commissione preferisce fingere di no. «È come dire che, anche se vediamo una mela, con tutte le caratteristiche di una mela, non dobbiamo chiamarla mela. L’essenza però non cambia», conclude il professore. Tutto sta a capire a chi spetterà il primo morso, se ancora agli Stati o all’Unione.