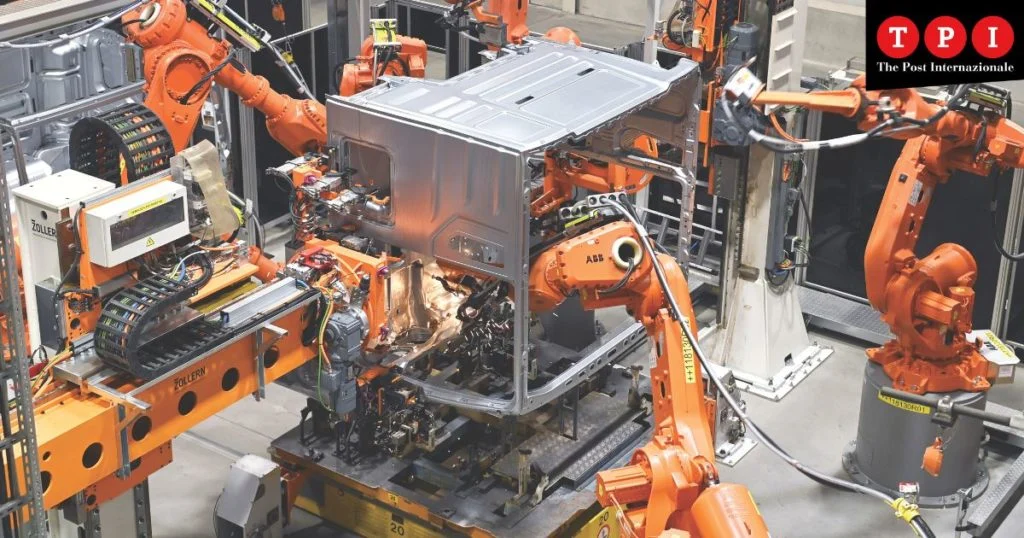In quella notte torrida di settembre Mahin era convinta che da lì a poche ore sarebbe morta assassinata per mano di suo padre e dei suoi tre fratelli maggiori. Poco più che 24enne, avevano scoperto due anni prima che era lesbica, e che non avrebbe mai voluto sposare l’ennesimo uomo che il padre aveva scelto per lei come marito per il resto dei suoi giorni. Nata e cresciuta a Shiraz, era riuscita a custodire il suo indicibile segreto fino all’età di 22 anni, quando fu sorpresa in atteggiamenti intimi con la sua storica amica e compagna di classe Shadi nella sua camera da letto.
A tenerla sveglia nel caldo afoso della sua città natale iraniana, Shiraz, erano le voci dei suoi familiari che stavano discutendo sul modo migliore per ucciderla e nascondere il suo cadavere nel deserto, a poche decine di chilometri di distanza dalla casa in cui era nata e cresciuta. Era diventata una vergogna troppo ingombrante per tutta la famiglia, che da settimane aveva cominciato a meditare sull’opportunità di cancellare per sempre ogni sua traccia. «La legge islamica che osserviamo ce lo consente, possiamo ucciderla e liberarci di una peccatrice», li sentiva bisbigliare attraverso i muri. Fu in quel preciso istante che Mahin decise di arrendersi, uscire dalla sua stanza e accettare di sposare un uomo 20 anni più grande di lei, un cliente prosperoso del negozio del padre, e rinunciare per sempre alla sua identità. «Lo sposerò, basta che non mi uccidete».
Dall’inferno al purgatorio
Mahin oggi ha 47 anni, ed è una dei circa 200 rifugiati iraniani Lgbtq+ che vivono a Eskişehir, città dell’Anatolia Centrale in Turchia divenuta da più di 20 anni per volontà delle Nazioni Unite luogo di residenza e attesa per gli iraniani queer che scappano dalle persecuzioni del regime. Come per tutti gli altri rifugiati Lgbtq+, la Turchia è il Paese nel quale Mahin sperava di restare meno tempo possibile, in attesa di essere trasferita in Canada subito dopo che l’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr) le avesse riconosciuto ufficialmente lo status di rifugiata. Nonostante oggi Mahin sia riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, sono passati più di 7 anni e si trova ancora bloccata in Turchia, in una città dove «il livello di omofobia e transfobia è talmente elevato che ci fa desiderare di morire quasi ogni giorno».
Rispetto ad altri, Mahin è stata fortunata. Molti altri rifugiati iraniani gay e trans aspettano il loro trasferimento in Occidente da 10, 15 o persino 20 anni dal giorno della fuga dall’Iran, uno degli ultimi 7 Paesi al mondo che ancora conserva la pena capitale per i propri cittadini omosessuali. L’Unhcr non è in grado di fornire alcun tipo di tutela legale per la maggior parte dei rifugiati. A sostenerli è International Railroad for Queer Refugees (Irqr), una ong canadese fondata da Arsham Parsi, un ex rifugiato iraniano che ha vissuto la stessa odissea in Turchia per poi trovare rifugio in Canada nel 2006. Attraverso un complesso sistema di tutele legali, l’Irqr e la gemella Merjan Foundation seguono le vite dei rifugiati in Turchia cercando di raccogliere fondi per promuovere le sponsorizzazioni volte a trasferire le persone Lgbtq+ iraniane in Canada, la maggior parte delle volte a Toronto, per cominciare una nuova vita.
Le vite dei rifugiati iraniani queer sono tutte costellate dagli stessi dolori dovuti alle discriminazioni e alle violenze brutali delle autorità del regime iraniano e delle famiglie rigorosamente osservanti della sharia, la legge islamica che punisce con la pena di morte, l’ergastolo o uno spropositato numero di frustate i cittadini che sono colti in atteggiamenti intimi, sessuali o sentimentali con persone dello stesso sesso. Eppure, ogni storia di questi rifugiati racchiude in sé un universo di sofferenze uniche. Eskişehir è così diventata la città-rifugio turca di queste persone che da tempo aspettano di vivere la loro porzione di libertà nel mondo. Scappati da una terra di violenza e persecuzione, la Turchia non è però il migliore dei luoghi in cui potersi definire gay, lesbica, bisessuale o trans e vivere una vita serena e dignitosa.
Per questi rifugiati, trasferirsi dall’Iran alla Turchia è come spostarsi dall’inferno ad un purgatorio che sembra non avere mai fine. Chiedere asilo politico in altri Paesi sarebbe più complicato, perché la Turchia è l’unica nazione relativamente sicura che non richiede alcun tipo di visto per i cittadini iraniani al loro ingresso negli aeroporti. Fuggire verso l’Unione europea o il Nord America resta fuori discussione.
Dittatura privata
Mahin si presenta all’appuntamento per essere intervistata con cinque minuti di anticipo. Ha accettato di raccontare la propria storia a patto che venga cambiato il suo nome. Aspetta impaziente all’esterno di una sala da tè di Eskişehir per poi telefonare ininterrottamente allo scoccare preciso dell’orario stabilito per l’incontro. Nonostante i 47 anni, Mahin mostra un volto incredibilmente giovane, curato nel minimo dettaglio con un trucco leggero ma ben visibile. I capelli biondi e lunghi raccolti in una coda di cavallo ordinata, gli orecchini pendenti e brillanti, unghie con smalto rosso. Siede composta, con l’espressione del viso sereno, ma estremamente serioso.
E comincia: «La mia infanzia e la mia adolescenza sono state segnate da due dittature, quella di mio padre e quella dei miei tre fratelli maggiori».
Mahin era la settima di otto figli, nata in una famiglia di Shiraz fedele alla tradizione e alla dottrina islamica. Il padre, un noto commerciante di un negozio di generi alimentari della città, ha preteso che le sue tre sorelle maggiori si sposassero all’età di 12, 13 e 15 anni. Mahin avrebbe dovuto seguire lo stesso destino, ma ha sempre cercato di posticipare la data del matrimonio forzato urlando e piangendo senza sosta tutte le volte che il padre le portava a casa un pretendente.
«La violenza di mio padre è stata una costante durante la mia infanzia. Sin da quando avevo 8 anni ha cominciato a picchiarmi tutte le volte che non riuscivo a digiunare durante il Ramadan o durante le punizioni che puntualmente mi dava», dice.
Mahin ha sempre saputo in cuor suo di essere lesbica, fin dall’inizio delle scuole elementari. Essendo le scuole iraniane divise per sesso, circondata da sole ragazze, anno dopo anno si sentiva sempre più estranea ai discorsi sui ragazzi che sentiva quotidianamente dalle compagne di classe. A 14 anni erano tutte pronte per sposarsi e diventare madri, tranne lei. Quando provava a parlarne con la madre riceveva in cambio dei lunghi silenzi o dei semplici: «Devi obbedire a ciò che tuo padre sceglierà per te».
Fin quando un giorno scopre che una sua compagna di classe aveva le sue stesse “attrazioni”.
Comincia così all’età di 14 anni una lunga relazione platonica con la sua compagna di classe Shadi, fatta solamente di pomeriggi di studio passati insieme chiuse in camera da letto, lunghe chiacchierate, abbracci e baci delicati e sporadici.
«I momenti passati con Shadi sono le uniche memorie dolci che ho della mia adolescenza. Studiare insieme era la nostra unica via di fuga. Facevamo lunghi discorsi sull’inutilità degli uomini nel mondo, ci chiedevamo perché Dio li avesse creati, e ci promettevamo a vicenda che in un’altra vita ci saremmo sposate e amate per sempre», racconta Mahin fissando un punto vuoto nello spazio, con estrema concentrazione.
Mahin però non rivela a Shadi di essere oggetto di violenza e abusi sessuali da parte del padre e dei fratelli maggiori, che avevano capito che Mahin era diversa dalle sorelle e dalle altre donne del quartiere, e che non avrebbe accettato di sposarsi. «Uno dei miei fratelli maggiori era solito spiarmi mentre ero nella mia camera da letto e in bagno e ricordo vividamente quando una notte entrò nella stanza in cui dormivo e cercò di violentarmi. Non potei resistere. Anche in quell’occasione mia madre mi disse che era colpa mia perché non avevo “coperto abbastanza le mie curve”».
Mahin descrive la madre come una «soldatessa e una schiava» di suo padre. «Una volta mi disse che avrei dovuto accettare tutto ciò che mio padre mi avrebbe ordinato, incluso lasciarmi decapitare qualora lo avesse desiderato», racconta. «Non potrò mai dimenticare la notte in cui rifiutai di sposare mio cugino, che era appena tornato dalla guerra tra Iran e Iraq. Mio padre mi frustò così violentemente che sanguinai per tre giorni senza ricevere alcuna cura. Mia madre era lì che osservava la scena soddisfatta, incitando mio padre a frustarmi più forte. Andò avanti per quattro ore, fin quando non svenni dal dolore. Entrambi, con i miei fratelli, mi urlavano che ero “la vergogna della famiglia”».
Due mesi dopo, pochi giorni prima che fu messa di fronte all’«ultimo pretendente« che suo padre volle proporle, Mahin venne scoperta da uno dei suoi fratelli in atteggiamenti intimi con Shadi, in camera da letto. Quando il padre lo venne a sapere, si consultò col resto della famiglia e decise che era giunto il momento di ucciderla. Mahin riuscì ad origliare la conversazione, e per paura decise di accettare l’ultima offerta di matrimonio. Da quel giorno Mahin non avrebbe mai più rivisto Shadi.
Dopo soli 9 giorni, era già moglie di un uomo mai visto prima in tutta la sua vita, colui che Mahin definisce come «il mio terzo dittatore».
In 3 mesi Mahin si ritrovò incinta, dopo essere stata violentata ripetutamente dal marito, un uomo con seri problemi di alcolismo. «Diedi vita a mio figlio in un forte stato depressivo, ma dissi a me stessa che avrei cresciuto quel bambino come un uomo nuovo, diverso da mio padre, i miei fratelli e mio marito. La mia depressione post-partum mi fece vedere quel bambino come il quarto dittatore che mi avrebbe rovinato la vita. Ma sapevo che avrei potuto cambiare il corso delle cose».
Quando il marito cominciò a viaggiare lontano da Shiraz per lavoro, Mahin fu autorizzata a lavorare come segretaria in una clinica privata della città. Fu allora che si rifece vivo dopo 8 anni il suo fratello minore, l’unico che non l’aveva mai giudicata, e che soprattutto non aveva mai abusato di lei. Quel loro incontro cambiò la vita di Mahin per sempre, in tutta la sua imprevedibilità.
«Mio fratello mi salutò, mi disse che poteva leggere nei miei occhi uno stato di morte. Mi prese le mani e mi consegnò una Bibbia in Farsi, dicendomi di fare attenzione per non essere scoperta, e che lì avrei trovato un nuovo senso alla mia vita», dice.
Nel settembre 2008 il parlamento iraniano ha varato un nuovo codice penale che prevede la pena di morte per gli apostati e per coloro che lasciano l’Islam. La conversione dall’Islam al cristianesimo è quindi assolutamente proibita per tutti i cittadini nati e cresciuti sul suolo iraniano. Tuttavia, in tutto il Paese sono presenti associazioni clandestine di convertiti cristiani, che in gran segreto si riuniscono quotidianamente per leggere e studiare la Bibbia, e per esercitare riti religiosi, in genere in appartamenti privati o in seminterrati segreti nei condomini.
Questo era ciò che faceva il fratello di Mahin, che riuscì a convincerla a unirsi a lui regalandole «una nuova vita».
Di vergogna in vergogna
Per Mahin fu però l’inizio di un nuovo percorso tormentato e di ostacoli inaspettati. «Ero felice per la prima volta nella vita, mi sentii accolta da una comunità che poteva capire i miei dolori e che mi aiutò a cominciare un percorso di perdono verso chi mi aveva fatto del male senza pietà», dice.
Fin quando un giorno una sua collega a lavoro notò il «libro strano» che Mahin leggeva ogni giorno di nascosto. La sua collega, figlia di una delle autorità religiose di Shiraz, rivelò tutto al padre, che il giorno dopo mandò due ufficiali della polizia nella clinica in cui lavorava Mahin per arrestarla. Non appena Mahin varcò l’ingresso della clinica, fu prelevata di forza dai due agenti, bendata e scortata immediatamente nella stazione principale di Shiraz.
Ciò che ha vissuto da quel momento resterà per sempre uno dei suoi incubi peggiori. All’arresto seguirono infatti quattro giorni di interrogatori serrati circa la comunità cristiana clandestina che Mahin aveva cominciato a frequentare col fratello. Una delle regole principali però era la segretezza, e Mahin decise di restare fedele alla sua comunità e non svelare alcun dettaglio alla polizia sulla chiesa che frequentava. Dal secondo giorno l’interrogatorio cominciò a diventare sempre più intenso, fino a trasformarsi in una violenza di gruppo nei confronti di Mahin.
«D’un tratto tutto il male del mondo era ripiombato nella mia vita senza che nemmeno potessi accorgermene», dice. «Ho subito tre giorni di torture, violenze sessuali e psichiche di cui ancora porto i segni lungo tutto il mio corpo. Hanno abusato di me in ogni modo possibile, insultandomi senza tregua. La mia mente era come paralizzata, mi sembrava di essere tornata agli orrori che ero costretta a vivere con mio padre e i miei fratelli».
Al quarto e ultimo giorno Mahin firmò un documento in bianco, promettendo alla polizia che non avrebbe più frequentato alcuna chiesa cristiana. Dopo aver firmato il foglio le fu detto che qualora fosse stata arrestata una seconda volta «avrebbero agito in modo differente», lasciandole intendere che sarebbe stata punita con la pena di morte. Fu bendata e lasciata sul ciglio della strada nel deserto alle porte di Shiraz. Mahin riuscì a tornare a casa in forte stato confusionale dopo due giorni di autostop.
Informato dalle autorità, suo marito picchiò violentemente Mahin, e decisa di chiuderla in casa obbligandola a lasciare il lavoro. Dopo un mese di profonda depressione, Mahin si decise a tornare in chiesa grazie al supporto emotivo del fratello minore e di una delle sorelle maggiori, anche lei convertita al cristianesimo. Ma nel giro di due mesi vennero a sapere che la polizia era arrivata a scoprire il luogo in cui si tenevano i riti clandestini, e che presto tutti i membri della chiesa sarebbero stati arrestati e processati.
In poco meno di 48 ore Mahin e i suoi fratelli decisero di prendere il primo volo per Ankara, in Turchia, e non tornare mai più. Senza avvisare il marito, decise di portare con sé suo figlio di 15 anni. Oppresso anche lui dalle violenze del padre alcolista, non ci pensò due volte e partì con la madre.
Una volta arrivati ad Ankara si presentarono nell’ufficio dell’Unhcr per chiedere protezione in quanto rifugiati cristiani costretti a lasciare l’Iran. Mahin decise durante il suo colloquio individuale con il funzionario dell’Onu di non rivelare nulla circa la sua identità di donna lesbica oggetto di violenza per una vita intera. Il timore che suo fratello potesse anche solo minimamente sospettare del suo orientamento sessuale la mandava infatti in uno stato di forte ansia.
I suoi timori erano più che fondati. «Mandati dall’Onu a Eskişehir, in Turchia, mio fratello fu subito nominato dalla comunità cristiana iraniana locale uno dei principali pastori. Un giorno scoprì che stavo frequentando una donna lesbica che avevo conosciuto nel mio primo lavoro come donna delle pulizie. Andò su tutte le furie e mi disse che se avessi assecondato il mio orientamento sessuale mi avrebbe disconosciuta come sorella per tutta la vita. Mi disse che dopo essere stata la vergogna della famiglia in Iran, non avrebbe mai potuto permettere che diventassi la vergogna della famiglia anche in Turchia», racconta.
A questo punto dell’intervista dobbiamo interromperci su richiesta della mia traduttrice, Sanaz, una studentessa di 32 anni fuggita in Turchia da Tehran, che mentre bisbiglia le ultime parole tradotte di Mahin si mette le mani in faccia ed esplode in un pianto liberatorio, chiedendo di allontanarsi per qualche minuto. La carica emotiva si è fatta troppo alta.
Il fratello di Mahin la cacciò quindi di casa insieme al figlio, ma non le diede la libertà di lasciare la chiesa in cui lui è pastore, o di cambiare chiesa a Eskişehir. Nessuno infatti tra i cristiani iraniani presenti a Eskişehir avrebbe dovuto sospettare di una loro rottura familiare. Ancora oggi Mahin è costretta a presentarsi tutte le domeniche nella chiesa in cui il fratello è pastore, proprio per non destare alcun sospetto.
Nel limbo
Nessuno in Turchia ha mai saputo nulla riguardo l’orientamento sessuale di Mahin, fin quando un giorno un rifugiato gay iraniano, Mehran, la intravide sul posto di lavoro, nell’industria metallurgica in cui lei era donna delle pulizie e Mehran aveva da poco trovato lavoro come saldatore.
«Mehran mi fissava ogni giorno. Avevo paura che prima o poi avrebbe abusato di me, dato che alcune ex colleghe mi avevano messo in guardia sull’alto numero delle violenze sessuali sul posto di lavoro a Eskişehir», dice. Un giorno Mehran trovò il coraggio di avvicinarsi a lei, dicendole in Farsi: «Sono cristiano anche io, e sono gay, come te».
Da quel giorno i due hanno stabilito un’amicizia solida, seppur nella massima segretezza e confidenzialità. Ed è proprio grazie a Mehran se Mahin è venuta a contatto tramite Instagram con Arsham Parsi, l’amministratore delegato di International Railroad for Queer Refugees, l’ong che sostiene i rifugiati iraniani Lgbtq+ che vogliono lasciare la Turchia per recarsi in Canada.
Mahin e suo figlio di 22 anni oggi sono nella lunga lista di attesa dei rifugiati iraniani che aspettano di essere sponsorizzati e partire per il Canada. Mahin sa di essere «tre volte rifugiata iraniana» per la sua condizione di donna abusata ripetutamente, lesbica e cristiana. Quando le viene chiesto cosa la fa restare ancora aggrappata alla speranza di sopravvivere al suo passato fatto di tanti altri dolori indescrivibili, lei risponde con fermezza: «Mio figlio. L’unico motivo per cui oggi desidero sopravvivere e lasciare la Turchia è quello di dare un futuro libero a mio figlio, e crescerlo come un vero uomo».
Anche Mehran, 42 anni, vive il limbo dell’attesa in Turchia come rifugiato gay da ormai 7 anni. Ma a differenza di tutti gli altri rifugiati Lgbtq+ iraniani, a inizio gennaio 2023 Mehran ha finalmente ricevuto la telefonata dall’ambasciata canadese in Turchia che aspettava da tempo. Il suo permesso di soggiorno è stato approvato, e grazie al supporto della Merjan Foundation, organizzazione gemella di Irqr, lascerà Eskişehir per trasferirsi a Toronto.
Nato e cresciuto in una piccola cittadina nel Kurdistan iraniano, Mehran ha sempre saputo di essere gay. «Man mano che crescevo, nonostante sapessi che avrei potuto correre spesso il rischio di venire ucciso per il mio orientamento sessuale, non me ne sono mai fatto una vergogna, e non ho mai ricevuto alcuna forma di violenza da parte dei miei familiari», spiega. Entrambi i genitori di Mehran sono sempre stati politicamente impegnati nella politica locale, conducendo battaglie contro il regime dell’ayatollah Khamenei, spesso assentandosi da casa.
Anche per questo motivo Mehran riuscì a mantenere una lunga relazione stabile di 8 anni, seppur clandestina, con un impiegato della prosperosa azienda di forniture di gas da lui fondata quando aveva solo 28 anni. Nel 2016 però il suo compagno fu costretto dai genitori a sposare una donna, dalla quale ha poi avuto un figlio.
«Capita ancora oggi di sentirci nonostante la distanza. Lui ancora mi cerca, e credo sia ancora innamorato di me. Quando dovetti scappare in Turchia come rifugiato politico insieme alla mia famiglia nel 2008, decisi di rientrare in Iran solamente perché il mio compagno era ancora lì. Ma quando lasciai definitivamente l’Iran nel 2016 io gli proposi di scappare con me e lasciare tutto, ma lui mi comunicò che sarebbe rimasto con la sua nuova famiglia», dice.
Per Mehran la fine della sua relazione ha rappresentato uno degli ostacoli più grandi di tutta la sua vita, superata solamente grazie a due anni di terapia. In questo periodo di auto-analisi, Mehran ha dovuto affrontare anche un trauma legato ad un episodio di violenza di stampo omofobico che lo ha reso «spaventato a vita».
Tornato alla vita da single, decise di rimettersi in gioco e creare un profilo sull’app di incontri gay più famosa al mondo, Grindr, che in Iran e in molti altri Paesi di cultura islamica è vietata e accessibile solamente grazie ad una connessione VPN. Dopo aver chattato per poco più di due mesi con un ragazzo gay della sua stessa città, scambiando foto e informazioni private, Mehran si sentì pronto per un incontro dal vivo, pensando di potersi finalmente fidare di una nuova persona con cui uscire.
Quel giorno però ad aspettarlo all’appuntamento a casa del ragazzo con cui aveva parlato c’erano altri due uomini, che dopo averlo colpito alla testa abusarono di lui per tutta la notte, facendo più filmati dello stupro con i loro cellulari. Durante queste violenze Mehran fu accoltellato due volte nello stomaco mentre cercava di difendersi. Capì che non avrebbe più potuto fermare la loro furia, che durò per ore interminabili.
Una volta abbandonato per strada, Mehran non ebbe il coraggio di denunciare l’accaduto alla polizia per la vergogna, perché sapeva che non avrebbe mai potuto confessare di essersi recato ad un appuntamento in quanto uomo gay. Decise anche di non andare in ospedale per non destare alcun sospetto. Derubato di tutto ciò che possedeva di prezioso quella notte, i suoi bracciali, una collana d’oro e il suo portafogli, divenne vittima di ricatti dei suoi 3 stupratori. Cominciarono a chiedergli denaro, altrimenti avrebbero diffuso in rete i video dello stupro, in cui era chiaramente visibile il suo volto e quindi riconoscibile la sua identità.
Nei successivi 5 mesi Mehran acconsentì a pagare 12 milioni di rial iraniani al mese a ciascuno dei suoi aguzzini, fin quando, ricadendo in depressione, si accorse di stare prosciugando tutto il denaro che gli era rimasto e che aveva guadagnato in anni di fatica nell’azienda che aveva fondato. Dovette licenziare a poco a poco tutti i suoi dipendenti, compreso il suo ex compagno, per poi decidere di chiudere una volta per tutte e lasciare l’Iran per sempre.
Supportato dalla famiglia in questa scelta, arrivato ad Ankara, in Turchia, Mehran non aveva un posto in cui dormire e quasi zero risorse economiche per pochi giorni, senza contare che non aveva mai parlato una parola in turco in tutta la sua vita. «Mi ritrovai solo al mondo e sopraffatto dalla paura. Il dolore più grande mi fu dato all’Unhcr quando a stento credevano a tutte le storie che avevo raccontato su ciò che mi stava accadendo in Iran. Non mi sentivo preso sul serio e questo mi faceva stare male», dice.
Per Mehran ci vollero infatti ben 10 mesi prima che potesse ricevere lo status di rifugiato. In questo lasso di tempo però, grazie al supporto di un amico gay che anni prima era fuggito a Eskişehir, Mehran venne a contatto con Irqr e decise di trasferirsi anche lui nella città dell’Anatolia centrale. Da sempre cristiano, Mehran pensò di trovare l’accoglienza di cui aveva bisogno nella chiesa iraniana di Eskişehir, dove però si rese conto fin da subito anche lì dell’omofobia dilagante.
«Riesco a pregare solamente quando sono solo, altrimenti mi sentirei giudicato anche lì. Ho visto con i miei occhi delle persone trans iraniane che cercavano protezione nella stessa chiesa essere buttate fuori con estrema violenza, ricoperte da insulti che ferirono anche me nel profondo», dice, ammettendo rassegnato che «Eskişehir e la Turchia non potranno mai essere luoghi del tutto sicuri per noi iraniani Lgbtq+”.
La vita che Mehran ha trascorso a Eskişehir è stata infatti segnata da sacrifici, violenze e solitudine. Nonostante avesse lasciato in Iran un lavoro altamente qualificato, è stato estremamente complicato per lui persino trovare lavori in nero o poco pagati. Più volte si è sentito discriminato in primis perché iraniano, e la maggior parte delle volte perché gay, «anche se ho sempre cercato di nascondere la mia identità, lasciandomi crescere la barba, camuffando la mia voce e ovviamente abbandonando ogni desiderio di incontrare nuovi ragazzi».
Fin dal suo arrivo a Eskişehir, Mehran ha provato a lanciarsi in numerosi lavori per provare a pagare un affitto tutto per sé, appoggiandosi quindi in un primo periodo a casa di un amico iraniano che lo ospitava clandestinamente. Ha lavorato come lavapiatti, uomo delle pulizie, aiuto cuoco, guardiano notturno, sempre sottopagato e «maltrattato», per poi trovare un lavoro stabile come saldatore in una delle principali industrie metallurgiche di Eskişehir.
«Ho lavorato per cinque anni 6 giorni a settimana, per 12 ore al giorno. Non avevo la preparazione adeguata per fare il saldatore, e questo mi è costato caro perché mi sono procurato tre volte serie ustioni e scottature sulle mani e sulle braccia», dice. In tutti gli infortuni che ha avuto e che lo hanno costretto a rimanere a casa per settimane, Mehran non ha mai avuto accesso ad alcun tipo di assicurazione sanitaria pubblica o privata. Anche il suo stipendio di 5mila lire turche mensili è sempre stato di gran lunga inferiore a quello dei suoi colleghi turchi, che per le sue stesse mansioni guadagnano 8mila lira turche.
A differenza però della maggior parte degli altri rifugiati gay, Mehran presto potrà ricordare Eskişehir solamente come un periodo oscuro della sua vita ormai volto al termine. Quando gli viene chiesto qual è il suo desiderio più grande per la sua nuova vita che lo aspetta in Canada, risponde: «Voglio un fidanzato, vorrei una relazione che non sia violenta e libera da ogni paura».
Afferra con le dita il crocifisso che ha al collo, accanto a una medaglia di San Francesco di Assisi, e dice: «Cercherò solo un po’ di pace».
La prigione del corpo
Probabilmente, la pace interiore Shahin non l’ha mai conosciuta, o nemmeno lontanamente assaporata. I pochi amori che ha incontrato nel suo cammino sono sempre stati contraddistinti dall’ansia di essere scoperto o dal terrore di essere malmenato a morte, come infatti è accaduto fin troppe volte.
Shahin ha 40 anni, di cui solamente uno trascorso ad Eskişehir come rifugiato trans F-to-M. Basso di statura, si presenta all’appuntamento per essere intervistato con fare timido e serioso. Barba incolta e disordinata sul viso, indossa jeans sportivi e stracciati, una felpa blu scuro e due semplici orecchini in legno. Sorride teso e ordina un tipico tè turco che lascerà raffreddare per le successive quattro ore, in cui non risparmierà alcun dettaglio della sua storia che l’ha portato in Turchia.
Nato e cresciuto donna per poi diventare uomo in età adulta (nel corso di questa storia riferendosi a lui verranno usati pronomi al maschile), Shahin era l’ultimo di dieci figli di una famiglia tradizionale e profondamente religiosa di Ardabil, città dell’Azerbaijan persiano, nel nord-ovest dell’Iran. «Da che ho memoria, fin dalla mia infanzia sono sempre stato sotto pressione, in quanto ero l’ultimo figlio, e soprattutto ero una bambina che avrebbe dovuto uniformarsi a tutto ciò che il sistema e che la mia famiglia avevano già deciso da tempo per me», dice.
L’unica persona alla quale Shahin si sentiva vicino era la sorella maggiore, più grande di 3 anni, con la quale era anche compagno di classe in un collegio tradizionalista per sole ragazze. La prima volta in cui Shahin fu picchiato dal padre avvenne quando fu sorpreso a giocare a calcio all’età di 7 anni con alcuni vicini di casa, tutti maschi. La sorella maggiore aveva provato a sconsigliargli di non interagire con loro, ma per Shahin giocare a inscenare matrimoni tra principi e principesse, o creare finte sale da tè per bambole, era come una tortura.
Quella prima violenza ricevuta tra le mura domestiche non fece che rendere la sua infanzia sempre più isolata e distaccata dai desideri che nutriva dentro per la sua vita. Come per ogni bambina iraniana, arrivò anche per lui il giorno di “Jashn-e Taklif”, la celebrazione tradizionale che segna per tutte le donne iraniane, all’età di 9 anni, il passaggio dall’infanzia alla vita adulta. Quel giorno a scuola insieme a tutte le sue compagne Shahin indossò per la prima volta un hijab, il velo islamico che copre il capo delle donne.
Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui