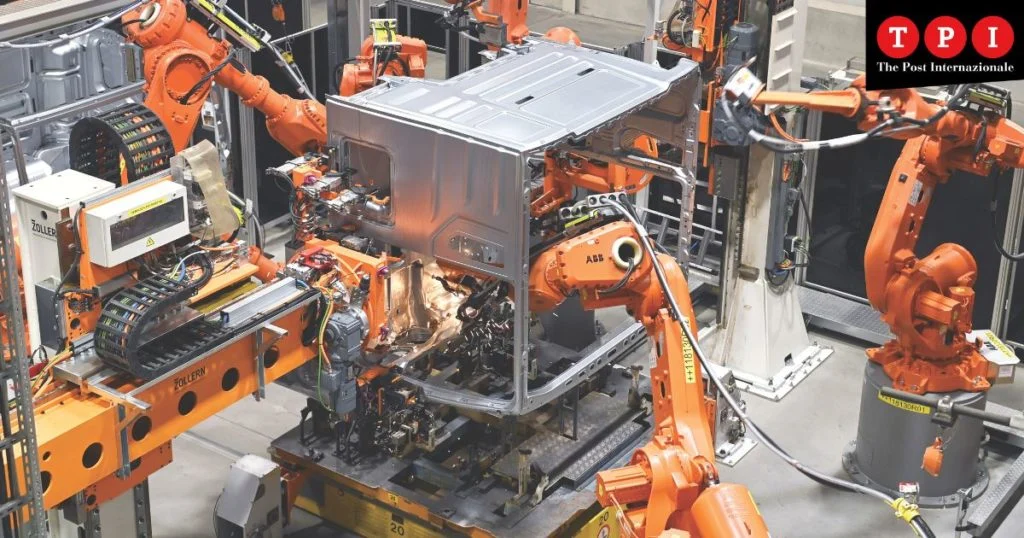Chi più si ricorda, dopo questo bombardamento apologetico, del giorno lontano in cui Silvio Berlusconi, terrorizzato dall’idea di una vittoria della sinistra che lo spogliasse delle sue televisioni, disse a Bettino Craxi: «Che cosa devo fare Bettino? A volte, se sono solo, mi capita perfino di mettermi a piangere, quando sono sotto la doccia…».
Lo scambio di battute, raccontato nel 1996 a Ezio Mauro da Ezio Cartotto, uno dei pochi giornalisti che all’epoca frequentavano Arcore, non è stato mai smentito da nessuno. Ed è clamoroso, a suo modo, almeno quanto la risposta ricevuta dal leader del Garofano davanti al testimone: «Silvio, tu ora puoi fare una sola cosa: sostenere la Lega e apparentarti con Bossi».
I giornalisti consiglieri, da Maurizio Costanzo e Giuliano Ferrara, come ha raccontato tante volte il conduttore del Mcs, ripetevano a Berlusconi: «Tieniti fuori dalla politica!». E gli amici democristiani, come Pier Ferdinando Casini, gli indicavano questa via di uscita: «Parla con Segni! parla con Segni! È un conservatore. Vi piacerete».
Già, Segni. È curioso che, nel diluvio di testimonianze di questi giorni su Silvio Berlusconi, nessuno abbia fatto ricorso alla più importante che abbiamo, proprio sulla scelta decisiva del Cavaliere: la «discesa in campo». Il motivo è semplice: nel furore agiografico che ha guidato le narrazioni di queste ore, l’aspirazione a “glassare” la biografia di Berlusconi ha portato a riscrivere l’agenda della storia, producendo vistosi buchi di narrazione e facendo persino scomparire alcuni passaggi fondamentali.
Patto saltato
Il primo di questi snodi cruciali è proprio quel giorno decisivo in cui si incontrarono l’allora editore della Fininvest e l’uomo che tutti indicavano come il futuro presidente del Consiglio. Berlusconi in realtà già in in quelle ore meditava la formazione di un partito tutto suo, un partito-azienda da poter controllare in maniera militare.
Mentre Segni aveva appena vinto il referendum che introduceva per la prima volta in Italia il sistema maggioritario e immaginava di poter ottenere dal Cavaliere copertura televisiva da parte di Mediaset e finanziamenti per la coalizione che meditava di costituire con il Ppi di Mino Matinazzoli.
Ma in quell’incontro, che dunque era stato convocato per stabilire un accordo di sostegno già scritto al leader del Patto per l’Italia, non ci fu nessuna empatia umana tra i due: Berlusconi rimase stupito, e persino disgustato da Segni, che gli apparve per nulla carismatico, un moderato irresoluto.
Così si convinse per la prima volta di due idee decisive. La prima: che nelle imminenti elezioni che si sarebbero tenute nel 1994 Segni avrebbe sicuramente perso. La seconda: solo un terzo polo che avesse unito la destra più radicale post-missina e quella antisistema della Lega, facendo dell’anticomunismo il suo primo motore elettorale, avrebbe avuto una possibilità di vittoria.
Bipolarismo
Si è detto: «Inventò il bipolarismo». Ma in realtà la vera intuizione politica di Berlusconi, in una competizione che fu in tutto e per tutto maggioritaria e tripolare, fu quella di trovare un modo per tenere unite tre cose che in apparenza non potevano stare insieme in nessun modo: la destra postmissina nazionalista, la Lega più secessionista e antisocialista, e le anime perse del Garofano e dello Scudocrociato raccolte intorno al nocciolo duro di Publitalia.
«Lei sta facendo una follia!», gli gridò quel giorno Mariotto Segni irritato, intuendo l’ambizione protagonistica di Berlusconi. E adesso sembra facile dire che sbagliò tutto (la sua coalizione centrista arrivò terza e lui non fu eletto nell’uninominale a Sassari, battuto da Carmelo Porcu di An, salvato dal proporzionale che voleva abolire).
In realtà l’idea assurda, e tuttavia geniale, in un tempo in cui Bossi chiamava Fini «Porcilaia fascista!» (ricambiato di ugual moneta), fu quella di costruire due distinte coalizioni. Una al Nord e una al Sud: la prima si chiamava “Polo delle libertà” (e teneva insieme Forza Italia con la Lega) la seconda “Polo del Buongoverno” (e teneva insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale).
Per tutta la campagna elettorale Lega e An continuarono a coprirsi di insulti, e a combattersi nei collegi settentrionali e meridionali, dove correvano separati. Ma ai fini del risultato elettorale fu del tutto irrilevante.
Studio scientifico
A dar colore a quella intuizione, e a spiegare come potesse essere realizzata, erano stati i sondaggi di un personaggio oggi totalmente dimenticato (fa il manager, commercia in gas) che all’epoca era poco più di un ragazzo. Era nato a Macomer, in Sardegna, non aveva ancora compiuto 29 anni, e fu il primo in Italia a imporre in politica l’uso scientifico degli studi demoscopici: il suo nome era Gianni Pilo.
Fu lui, con la sua Diakron, ad applicare per la prima volta il know how delle ricerche commerciali a partiti e dati elettorali. Fu con il suo sostegno che Berlusconi trovò la chiave per tenere insieme l’impossibile: «An non faceva perdere nessun collegio decisivo del Nord e portava voti determinanti per vincere al Sud, mentre la Lega faceva esattamente l’opposto». Nessuno pensava che questa possibilità esistesse, né dal punto di vista tecnico né da quello politico.
Cosmetica
Quando gli oppositori volevano irridere il Cavaliere gli stereotipi d’attacco erano sempre due: i tacchi e «la testa catramata». In realtà, prima della cosmetica arrivò un trapianto, eseguito da un serioso medico di Torino, il professor Buttafarro. E il successore di Pilo, Luigi Crespi, l’inventore del celebre «contratto con gli italiani» (altro esempio di scuola che racconta bene la fusione impossibile tra sondaggistica, politologia e propaganda), ha raccontato il più folgorante aneddoto su come Berlusconi percepiva il proprio corpo.
È una testimonianza che per me è forse la sintesi più forte del culto studiato da Marco Belpoliti in un saggio di grande successo sul berlusconismo, “Il corpo del Capo” (Guanda). Il Cavaliere non aveva solo le note velleità cosmetiche parodiate dai suoi detrattori, infatti, ma due certezze ferree. La prima era che la nuova comunicazione politica doveva essere prioritariamente televisiva. La seconda era che il corpo non fosse per un politico un elemento personale della propria identità, ma piuttosto un logo, un apparato liturgico neo-bizantino, una icona da modellare sulle esigenze della propaganda mediatica.
Ed ecco l’aneddoto folgorante di Crespi. Proprio nel giorno in cui gli proponeva il celebre slogan «Più pensioni per tutti», lo spin doctor meneghino (che passò sette anni alla Corte di Arcore) si trovò a litigare con un fedelissimo collaboratore di Berlusconi, Giampiero Comolli. Era la mattina in cui Crespi stava presentando al leader azzurro lo slogan che aveva immaginato per la cosiddetta «traversata del deserto», le elezioni politiche, cioè, che nel 2001 facevano seguito a cinque lunghi anni di opposizione.
Una legge voluta da Massimo D’Alema, passata al secolo come la “par condicio”, impediva spot elettorali. Così Berlusconi e Crespi avevano prenotato il 50% di tutti i manifesti pubblicitari presenti sul territorio nazionale. La più grande (e costosa) campagna pubblicitaria murale della storia italiana, secondo Crespi, doveva articolarsi intorno a uno slogan semplice e folgorante: appunto, «Più pensioni per tutti».
Berlusconi si mostrò entusiasta, ma secondo lo stesso Crespi era seccato del fatto che non ci fosse una sua grande foto a corredo dei poster. Il problema è che il Cavaliere, con grande cruccio, aveva appena perso tutti i capelli, e Crespi aveva deciso di puntare graficamente sul solo cognome, peraltro stampato a caratteri cubitali. Ecco perché il factotum Comolli, interpretando questo disagio, preparò in fretta e furia una foto ritoccata in maniera un po’ grossolana, dove Berlusconi aveva una selva di capelli fitti e scuri.
Crespi era insorto rivolgendosi a Berlusconi: «Ma, dottore, è grottesco! Gli elettori non possono vederla calvo nella realtà della campagna elettorale ma con capelli sui manifesti!». Comolli si mise a urlare per la lesa maestà: «Come ti permetti!?». E a quel punto l’uomo concavo e convesso diede prova della sua proverbiale capacità inventiva: «Scusa, Comolli. Crespi ha ragione…». E Comolli: «In che senso “ha ragione”?». E il Cavaliere: «Effettivamente sarebbe assurdo se ci fossero due Berlusconi, uno con i capelli e uno senza…».
Crespi sorrise, pensando di avere vinto. Però ecco il colpo di scena: «…Tuttavia, quando inizierà la campagna elettorale – concludeva il Cavaliere – io avrò di nuovo i miei capelli!». I presenti rimasero tutti di stucco. Ma accadde proprio questo, grazie al trapianto di Buttafarro, e alla celebre bandana che accompagnò il post-operazione, fotografatissima ed esibita a Villa Certosa durante un’altrettanto celebre visita di Tony Blair. Inutile dire che il Cavaliere vinse le elezioni di nuovo.
Delfini
Quanti sono stati gli eredi designati e i portavoce politici di Berlusconi? Sono quasi archeologici i ricordi della coppia d’oro Fabrizio Cicchitto-Sandro Bondi, con il toscano che ti rispondeva da Arcore mentre componeva carmi di laude al Cavaliere (lo tradì per passare all’Ncd). E pochi ricordano la breve carriera da front-woman di Elisabetta Gardini (oggi eurodeputata di FdI), un’avventura folgorante finita in un gabinetto di Montecitorio dopo una memorabile lite con Vlaldimir Luxuria per aver trovato il deputato transgender di Rifondazione Comunista nel wc riservato alle signore: «Esci subito!».
Ma persino a me capitò di intervistare la futura animalista Michela Vittoria Brambilla mentre il Cavaliere le regalava – nientemeno – una struttura di club, una tv e un quotidiano. La sua fine fu la stessa di Angelino Alfano, Alessandro Cattaneo, e tutti i delfini e i portavoce designati, con l’eccezione di Giovanni Toti, che ebbe la forza di iniziare la sua carriera con una celebre tuta bianca in un centro diete di Chenot, ma anche di riuscire a sopravvivere in cattività, costituendo addirittura un altro partito nel centrodestra. Stessa fine hanno fatto tutti i cerchi magici e le badanti.
La spiegazione è semplice: Berlusconi ha usato questo plotone di aspiranti leader – alcuni palesemente inadeguati, altri buoni – come uno specchietto per le allodole e un elisir, un metaforico ritratto di Dorian Gray: i suoi alter ego si consumavano e si bruciavano, lui ringiovaniva. Ecco perché Berlusconi non lascia nessuna eredità politica: perché non l’ha mai veramente voluta.
Cori
«E Forza Italia!!!! Che siamo tantissimi!!!», fu molto più che un inno, un jingle che ibridava perfettamente la lingua della televisione e quella della neopolitica berlusconiana. Non a caso, malgrado Berlusconi volesse accreditare l’idea di esserne l’autore occulto, era composto dal maestro Renato Serio e arrangiato da Augusto Martelli, ex marito di Mina, il geniale musicista che cucinava molte irresistibili musichette di Mediaset. Quel cd con l’inno di Forza Italia era dentro il mitico “kit del candidato”, e fu considerato una pacchianata di colore finché il ritornello non entrò nelle nostre teste (destinato a rimanerci per sempre).
Un giorno mi ritrovai ospite di Berlusconi a Palazzo Grazioli, e intorno al tavolo c’erano anche Debora Bergamini e Gianni Letta. Berlusconi mi disse: «Io sono più a sinistra di lei. Sono libertario, liberale, e sopratutto socialista». Provai a obiettare che era tuttavia anche il leader del centrodestra. Lui si mise a ridere, poi disse serio: «È vero. Ma la sinistra e il centro erano presidiati. Era l’unico spazio che fosse rimasto libero!». Ed ecco il marketing.
Così mi ritornò in mente quel dialogo con Segni, e il grande enigma di cosa sia stato il Berlusconismo in politica. Un’ideologia della prassi, senza dubbio, capace di tenere insieme il massimo dell’invenzione identitaria e della capacità di strutturare e destrutturare la narrazione intorno al mutare del corpo e delle idee del Capo.
«Il dottore» degli anni Settanta, «il Cavaliere» degli anni Ottanta, «il presidente» del Milan (e poi del Consiglio), il «liberale», il «conservatore», il «socialista», «l’amico di Putin», il padre «del nuovo miracolo italiano», «Sua emittenza», il marito tipo di «una famiglia italiana» e «il Papi» delle olgettine, il «mediatore» che tendeva personalmente i limoni finti con lo spago atlantico a Pratica di Mare, ma anche l’ultimo combattente filorusso che solo pochi giorni fa ripeteva: «Non incontrerei mai Zelensky!».
Ci sono stati uno-dieci-cento Berlusconi, tutti uniti dal fuoco di un culto catodico da moderno Re taumaturgo. E questo racconto potente, che non ammetteva la contraddizione spiacevole della realtà, ha attraversato la politica italiana, lasciando dietro di sé solo cloni e nani. Perché il corpo del Cavaliere, le sue ossessioni e le sue trovate, la sua lingua televisiva propagandistica, post-orwelliana e postmoderna, senza di lui non sono nulla.